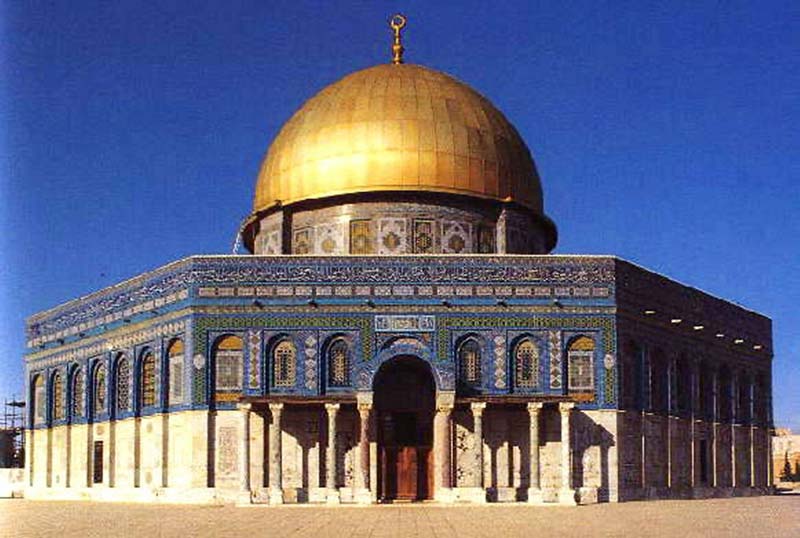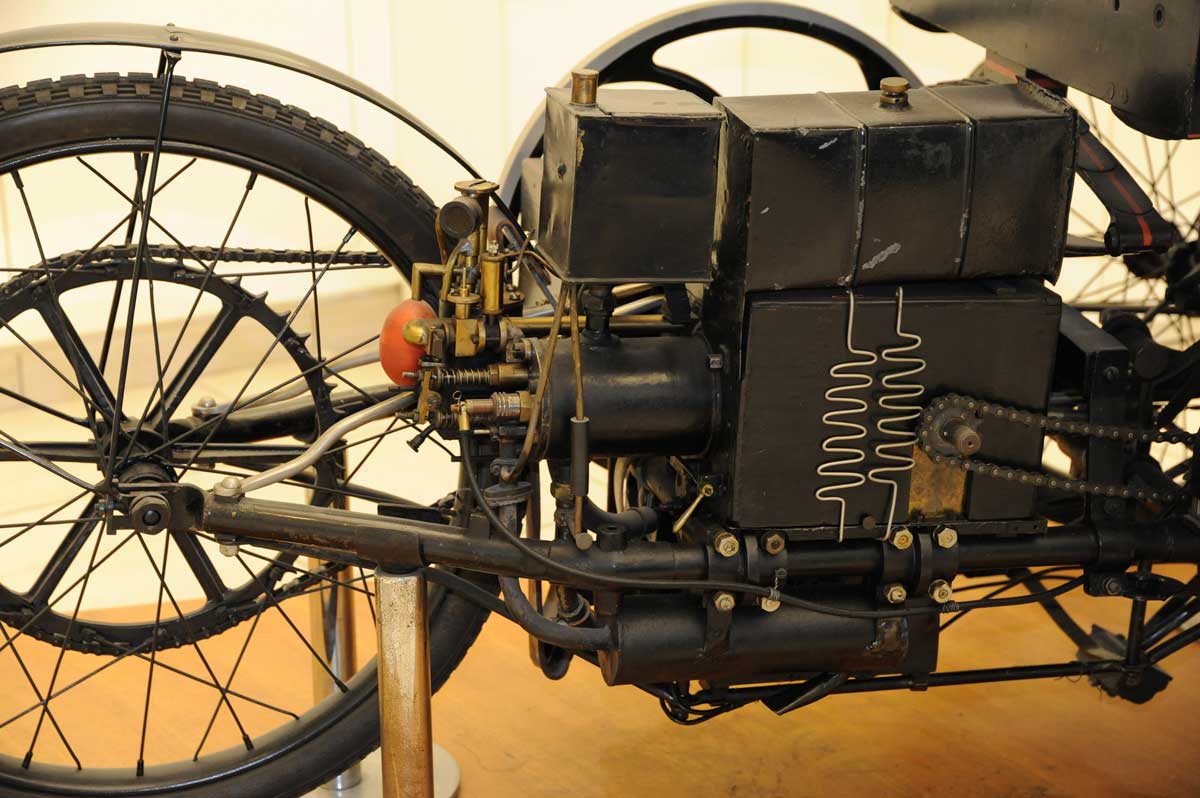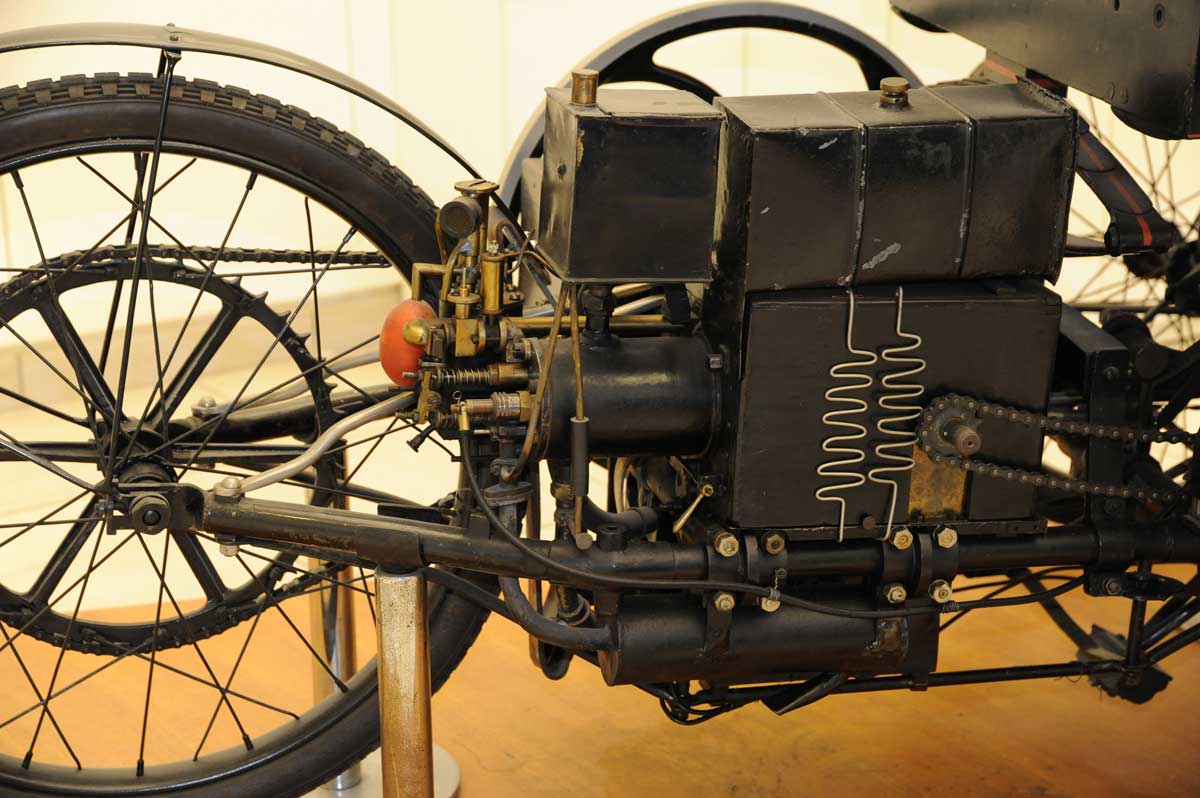![MAGLIETTE-DIALETTO.1200]()
AFARI: I PROVERBI AL SERVIZIO D’I AFARI
A far credenza se perde l’aventore.
A l’amo se ciapa el pesse, i òmani a l’intaresse.
A l’astuzia del munaro no gh’è mai nissun riparo.
A morire e a pagare se fa senpre tenpo.
Al ciaro de na candela no se stima né dona né tela.
Avere debiti e no pagarli xe come no averghene.
Basta na fontana a far dano a on’ostaria.
Bisogna fare la spesa secondo l’entrata.
Bon marcà sbrega la borsa.
Cavalo in prìstio no xe mai straco e no ga mai fame.
Chi che dispreza conpra.
Chi che ga paura del diavolo no fà schei.
Chi che paga avanti el trato, servizio mal fato.
Chi dà via el fato soo prima che’l mora, el merita la morte co la mazola.
Chi gira leca, chi sta a casa se seca.
Chi inpresta perde el mànego e anca la zesta.
Chi leze el cartelo no magna vedèlo.
Chi no se contenta de l’onesto, perde el mànego e anca el zesto.
Chi no tien conto de on scheo, no vale on scheo.
Chi pì spende manco spende.
Chi stima no conpra.
Chi va a Roma e porta on borsoto, deventa abate o vescovo de boto.
Chi vol vèndare mete in mostra.
Co’ canta le zigàle de Setenbre no conprare gran.
Co’ no ghe n’è, spèndarne; co’ ghe n’è tegner da conto.
Co’ piase la roba no se varda la spesa.
Co’ se barata, uno ride e staltro se grata.
Co’ se ga da pagare se cata tuti, co’ se ga da tirare no se cata nissuni.
Co’l gran se incurva el contadin se indriza.
Conpra poco e guadagna tanto.
Da tristi pagadori se tole ogni moneda.
Debito sputanà, debito pagà.
Dotori e preti no dà mai gnente a nissun.
Dove no ghe xe da guadagnare ghe xe da pèrdare.
El pèrdare xe parente del piànzare.
El prezo no lo fà l’aventore.
El prezo sgualiva tuto.
El rosso xe par l’avocato, la ciara par le spese e la scorza par chi che vinze.
Fato ben o fato male, dopo el trato se beve el bocale.
Fin che i barufanti tira la vaca uno pa’ i corni e staltro par la coa, l’avocato monze.
La roba bona no la resta in botega.
La roba bona no la xe mai cara.
La roba in mostra xe quela che no se vende.
La roba ordenà la vol èssare pagà.
Mejo on magro acordo che na grassa sentenza.
No ghe xe carne in becaria che presto o tardi no la vaga via.
Omo vivo pagarà, omo morto ga pagà.
On bel ciapare fà on bel spèndare.
On bon vèndare fà on bon guadagno.
Pesa justo e vendi caro.
Primo sparagno, primo guadagno.
Roba rara, roba cara.
Se piove a Pentecoste, tute le entrate no le xe nostre.
Stimar la roba in erba l’è on stimar de merda.
Tanto xe marcante quelo che guadagna che quelo che perde.
Tra i poariti se lega, tra i siuri se se frega.
Tra verità e busìa se vende la marcanzia.
Numero Proverbi: 57
AMORE: L’AMORE DALA PARTE DEL PROVERBIO
A voler ben a ‘na bela xe pecà, a ‘na bruta xe carità.
Amare e no éssare amà, xe come forbirse el culo senza vere cagà.
Amarse, ma no buzararse.
Amore de soldà, oncuò qua, doman là.
Amore fa amore, cativeria fa cativeria
Amore, merda e zéndare le xe tre robe tèndare.
Amore senza barufa fà la mufa.
Amore, tosse e panza no se sconde.
Assa che la mojère la comanda in casa: solo cussì la te struca e la te basa.
Baso no fa buso, ma xe scala par andar suso.
Baso par forza no vale na scorza.
Chi che zerca cavalo e fémena senza difeto, no’l gavarà mai cavalo in stala e fémena in leto.
Chi ciama Dio no xe contento, chi ciama el diavolo xe disperà, chi dise ahimè xe inamorà.
Chi pì ama pì bastona.
Chi vole el pomo sbassa la rama, chi vole la tosa careza la mama.
Co’ la fame vien drento par la porta, l’amore va fora pa’l balcon.
Dona bela e vin bon xe i primi che te assa in abandon.
Dove che ghe xe tose inamorà, xe inutile tegnere le porte sarà.
In amore nasse corajo se te magni del formajo.
L’amore del vecio sa da scaldaleto.
L’amore fà passare el tenpo, e ‘l tenpo fà passare l’amore.
L’amore no ciapa rùzene.
L’amore no xe fato solo de amore.
L’amore vecio no fà mai la mufa.
L’amore xe potente, ma l’oro onipotente.
La bona mojère fà el bon marìo.
Le bele par dileto, le brute par dispeto.
Magari polenta e pessin, ma na bela testa sol cussin.
Oci mori, rubacuori; oci bisi, paradisi; oci celeste fà inamorare; oci bianchi fà cagare.
Ocio celeste, ocio de dama; ocio moro, ocio da putana.
Ocio no vede, cuore no sente.
On baso, na forbìa: el baso xe nda via.
Par amore no se sente rason.
Piova o sole, le strighe va in amore.
Polenta senza sale, ma on bel viseto sol cavazale.
Quando che piove col sole le strighe fà l’amore.
Quando el merlo canta d’amore Febraro finisse.
Salute,amore, schei e tenpo par gòdarli.
Toso tanto studioso, toso poco amoroso.
Voltà el canton, passà la passion
Numero Proverbi: 40
AQUA: AQUA E TORNO VIA
A chi che no ghe piase el vin , che Dio ghe toga anca l’aqua.
A le prime aque de Agosto la tortora la va via.
A lavarghe la testa al molton, se consuma l’aqua e anca el saon.
Ala prima aqua de Agosto, pitoco te conosso.
Aqua che core no porta odore.
Aqua de Agosto, miele e mosto.
Aqua de Aprile, fromento sol barile.
Aqua passà no masena pì.
Aqua setenbrina, velen par la cantina.
Aqua turbia no fa specio
Bivi el vin e lassa l’aqua al mulin.
Bon come l’aqua de Lujo.
Chi che ghe fà la barba al musso perde l’aqua e anca el saon.
Co’ canta el galo sola rosà, core l’aqua par la carezà.
Co’l mulin xe senza aqua me toca bévare aqua; co’ l’aqua fà ‘ndare el mulin bevo del bon vin.
El pèrsego col vin, el figo co l’aqua.
El pesse ga da noare tre volte: prima intel’aqua, dopo intel’ojo e la terza ‘ntel vin.
El pesse guasta l’aqua, la carne la conza.
El riso nasse da l’aqua e ‘l ga da morire sol vin.
El sangue no xe aqua.
Giugno, Lujo e Agosto, né dona, né aqua, né mosto.
L’aqua de Giugno ruina el munaro.
L’aqua de Majo ingrassa el formento.
L’aqua de San Gaetano la tole l’afano.(7/8)
L’aqua de San Giacomo la fà miracoli.
L’aqua de San Gregorio fà ranpegare la végna.
L’aqua de San Joani guarisse tuti i malani.
L’aqua morta fà spuza.
L’aqua ronpe dove che no se crede.
L’aqua smarzisse i pali.
La fémena xe come l’aqua santa: tanto fà poca come tanta.
Le zuche vode le sta sora l’aqua.
Merda e aqua santa fà la racolta tanta.
Na bona aqua de Febraro vale pì de on loamaro.
On mulin in aqua e uno in casa.
Quando che l’aqua toca el culo tuti inpara a noare.
Se no te me vidi de San Giusepe patriarca, o che son perso o che son in aqua. (19/3)
Se piove ai quaranta Santi, aqua par altretanti.
Soto la neve, pan; soto l’aqua, paltan.
Vàrdate da prete, contadin, da comare vizin e da aqua par confin.
Numero Proverbi: 40
BESTIE: EL POSTO DELE BESTIE IN MEZO AI PROVERBI
A ‘la Madona del Rosario el pitaro* de passajo.(6/10) *(petirosso)
A ‘la Madona i pitari ne sbandona.
A ‘la Madona le quaie ne sbandona.
Ai can magri ghe va drio le mosche.
A l’amo se ciapa el pesse, i òmani a l’intaresse.
A l’osèlo ingordo ghe crepa el gosso.
A le prime aque de Agosto la tortora la va via.
A lavarghe la testa al molton, se consuma l’aqua e anca el saon.
A magnare el zervelo del pesse se deventa intelijente.
A San Benedìo le ròndene torna indrio.(21/3)
A San Francesco i tordi i va de furia.(4/10)
A San Gorgon passa la lòdola e ‘l lodolon.(9/9)
A San Luca le lòdole se speluca.(18/10)
A San Roco le quaie le va de troto.
A San Simon le lòdole a valon.(28/10)
A San Valentin el giazo no tien gnanca pì on gardelin.(14/2)
A Sant’Ana el rondon se slontana.(26/7)
A Santa Toscana i rondoni se slontana.(14/7)
Ai Morti e ai Santi i corvi sbandona i monti e i vien a pascolare ai canpi.
Ai ultimi de Setenbre, i fringuei par la tesa.
Al cao de là fa la pitona.
Al mese de Jenaro la gata va in gataro.
Al primo de Agosto l’ànara se mote a ‘rosto.
Ala de capon, culo de castron e tete de massara xe na roba rara.
Ala sera tuti buò, ala matina tute vache.
Anca na bruta sìmia pole fare on bel salto.
Bacalà a ‘la visentina, bon se sera e de matina.
Barbi e rane mai de Majo, parché i fa tristo passajo.
Beato l’Istà co tuti i pulzi e i zìmesi che’l ga.
Bela coa, trista cavala.
Bisogna tacare el musso dove che vole el paron.
Can che baja no mòrsega.
Can no magna can.
Canpa, cavalo, che l’erba cresse.
Carne de vaca e legno de figaro par far bela ziera al’amigo caro.
Caval bianco e bela mojèr dà senpre pensièr.
Caval, putana e persegar trent’ani no i pol durar.
Cavalo in prìstio no xe mai straco e no ga mai fame.
Cavalo vecio e servo cojon no inbroja el paron.
Chi che bastona el so cavalo bastona la so scarsela.
Chi che careza el mulo ciapa peàde.
Chi che ga le zuche no ga i porzei.
Chi che ga na vacheta ga na botegheta.
Chi che ga solo on porzelo lo ga belo, chi ga solo on tosato lo ga mato.
Chi che ghe fà la barba al musso perde l’aqua e anca el saon.
Chi che zerca cavalo e fémena senza difeto, no’l gavarà mai cavalo in stala e fémena in leto.
Chi co done va e mussi mena, i crede de rivare a disnare e no i riva gnanca a zena.
Chi da galina nasse, da galina ruspa.
Chi leze el cartelo no magna vedèlo.
Chi no ghe piase galina col pien, merita pache opure velen.
Chi piègora se fà el lupo se lo magna.
Chi sparagna el gato magna.
Chi vol magnare on bon bocon, magna l’oca col scoton.
Chi vol stare san pissa spesso come on can.
Chi vole el can se lo ciapa par la coa.
Co la caveza se liga i cavai, co la parola i òmani.
Co’ canta el ciò xe finio de far filò.
Co’ canta el galo sola rosà, core l’aqua par la carezà.
Co’ canta le zigàle de Setenbre no conprare gran.
Co’ ghe n’è massa le cioche se beca.
Co’ la vaca tien su el muso, bruto tenpo salta suso.
Co’ se xe mussi ala matina se lo xe anca ala sera.
Co’ te nassi scarognà, te scanpi dal musso e la vaca te tra.
Co’ te senti le racolete xe rivà la Primavera.
Co’ toneza de Jenaro chi ga quatro vache se ne magna on paro.
Co’l galo canta da galina, la casa va i ruina.
Co’l galo canta so la zena, se no xe belo se serena.
Co’l lovo* deventa vecio i can ghe pissa incoste. *(lupo)
Co’l sole tramonta i àseni se ponta.
Co’l sorze scanpa, la gata va al paese.
Col pan se fà balare i can.
Da on musso no se pole spetarse che peade.
Da San tin tuto, el pesse mena el coìn.
Dai a chel can che’l xe rabioso.
De drio d’i s-ciopi, d’i cavai davanti e distante dai mati.
De Febraro ogni gata va in gataro.
De istà ogni beco fà late, de inverno gnanca le bone vache.
De la Sensa le granseole fà partensa.
De note tute le vache xe more.
De Pasqua no ghe xe galina che no faza.
De pesse scanpà no se ne ga mai magnà.
Del pito el passo, del polo el volo.
Dime ludro, dime can, ma no dirme furlan.
Done, cani e bacalà no i xe boni se no i xe pestà.
Dove che comanda le done e ara le vache, se vede solo robe mal fate.
Dove che manca i cavai anca i mussi trota.
El bòvolo xe on pasto fin: bon par el vecio, bon par el putin.
El can de du paruni more de fame.
El capon xe senpre de stajon.
El gato sol fogolaro xe segno de miseria.
El loame de cavalo el fruta on ano e no sò qualo.
El male riva a cavalo e ‘l parte a piè.
El musso, co’l ga magnà el volta el culo ala grupia.
El naso d’i gati, i zenoci d’i òmani e ‘l culo dele fémene xe senpre fridi.
El paron xe el ragno, el contadin la mosca.
El pesse ga da noare noare tre volte: prima ‘ntel’aqua, dopo ‘ntel’ojo e la terza ‘ntel vin.
El pòvaro omo no fa mai ben: se more la vaca ghe vanza el fen, se la vaca scanpa e l fen ghe manca.
Fare i mistieri che no se conosse i dìnari i deventa mosche.
Fin che i barufanti tira la vaca uno pa’ i corni e staltro par la coa, l’avocato monze.
Galina vecia fà bon brodo.
Gato sarà deventa leon.
I cojuni del can e i schei del vilan i xe i primi mostrà.
I nostri veci ga magnà i capuni e i ne ga assà i proverbi.
In istà la vache va in montagna a fare le siore, e le siore va in montagna a fare le vache.
I òmani ala guera e le vache in montagna no se garantisse.
I primi capuni fà la coa bela.
I schei fà balare i sorzi.
I schei porta l’oca al paron.
L’arcobaleno ala matina bagna el beco ala galina.
L’avaro xe come el porco, che no’l xe bon che dopo morto.
L’ocio del paron ingrassa le bestie.
L’orto xe mezo porco.
L’ospite xe come el pesse: dopo tri dì el taca a spuzare.
L’ultimo ovo xe quelo che scoraja el musso.
La boca no xe straca se prima no la sa de vaca.
La coa massa longa xe quela che copa la volpe.
La morte del lovo xe la salute dele piègore.
La note xe fata pa’ i alochi.
La panza d’i preti xe el zimitero d’i capuni.
La parola liga l’omo, la corda el musso.
La piègora xe benedeta dal culo e maledeta dala boca.
La prima galina che canta ga fato l’ovo.
La testa del barbon xe el mejo bocon.
La vita xe come na scala par le galine: curta (drita) e piena de merde.
La zaresa pi bona la xe quela del merlo.
Le bestie se trata da bestie.
Le galine che va par cà, se no lebeca le ga becà.
Le mosche le va drio ai cavai magri.
Le ràcole ciama piova.
Le vache pissa, i manzi sbrissa e i bo’ veci xe quei che tira.
Libri, done e cavai no se inpresta mai.
Loame de porco no loama né canpo, né orto.
Magari polenta e pessin, ma na bela testa sol cussin.
Magnà i gànbari se ciucia anca le zate.
Magna la lana, ma salva la piégora.
Magna renghe e sardeluni: te conservarè i polmuni.
Marcante e porco stimalo dopo morto.
Marsoni friti e polentina, on fià de vézena e vin de spina.
Marzo el se fà vanti, el merlo el fà noze coi so canti.
Marzo sventolon, more la piègora e anca el molton.
Marzo, par quanto tristo che’l sia, el buò al’erba e ‘l cavalo al’onbrìa.
Mèjo on àseno vivo che on dotore morto.
Mèjo on ovo oncuò che na galina doman.
Mèjo on sorze in boca a on gato che on omo par le man de on avocato.
Merlo in te’l camin trema el contadin.
Mese de Agosto, colonbo rosto.
Na pena ala volta se pela l’oca.
Na serenada de note dura fin che on can fà le balote.
Na volta core el lièvore, na volta core el can.
Nela luna setenbrina la sardela se rafina.
No ghe xe gnente de pì bon che el colo del capon.
No se dise vaca mora se no ghe n’è on pelo.
No se pole far cagare i mussi par forza.
No tocare can che ròsega e zugadore che perde.
No xe colpa dela gata se la parona la xe mata.
Nose e pan, magnare da can.
Ogni can mena la coa, ogni mona vol dire la soa.
Ogni osèlo no conosse el bon gran.
Ogni mosca la fa la so onbra.
On galo senza cresta xe on capon, on omo senza barba xe on cojon.
On lièvore fra du can, on contadin fra du avocati, on malà fra du doturi: chi sta pèzo de luri!
On ocio ala gata e staltro ala paèla.
On omo in man del’avocato xe come on sorze in boca al gato.
Osèlo de s-ciapo no xe mai grasso.
Par l’Anunziata el rossignolo so la saca.
Pesse grosso magna pesse picolo.
Pitosto che le tarme la magna, xe mejo che i osei la bècola.
Polenta nova e osei de riva, vin de grota e zente viva.
Porco ingrassà no xe mai contento.
Prima de parlare bisogna fare come el galo, che prima de cantare el sbate tre volte le ale.
Putei e colunbi insmerda la casa.
Quando a Novenbre el vin no xe pì mosto, la pitona xe pronta par el ‘rosto.
Quando canta le grole* ghemo burasca par tri dì.
Quando ch’el gato dorme i sorzi bala.
Quando che manca el gran le galine se beca.
Quando che manca i cavai i mussi trota.
Quando che’l galo canta zo de ora, doman no xe pì el tenpo de ‘sta ora.
Quando che’l Signore vuole castigare uno el ghe manda l’ispirazion o de sposarse, o de torse on musso o on’ostaria.
Quando el merlo canta d’amore Febraro finisse.
Quando la ràcola canta, piova tanta.
Quando le nuvole vien dal mare, ciapa i buò e va a arare; quando le nuvole vien dal monte ciapa i buò e va ala corte.
Quando se vede la raìna se no piove oncuò piove domatina.
Quatro a on segon, du a on capon.
Rispeta el can par el so paron.
Sant’Antonio se ga inamorà de on porzeleto.
Santa Poinara, la vecia (galina) sora la caponara.
Se ‘l dì de San Martin el sole se insaca, vendi el pan e tote la vaca; Se ‘l va zo seren, vendi la vaca e tiente el fen.(11/11)
Se ciapa pì mosche co na joza de miele che co na bota de aseo.
Se la galina tasesse, nissun savarìa che la ga fato l’ovo.
Se Nadale vien senza luna, chi ga do vache se ne magna una.
Se piove sui cavajuni, bondanza de galine e ovi.
Sia da cavalo che da mulo sta tri passi lontan dal culo.
Suòre de stradin e grasso de mussolin guarisse tuti i mali.
Tanti can mazza on lovo* e on solo can baja a la luna. *( lupo)
Testa de musso no se pela mai.
Tien on ocio al pesse e ‘nantro al gato.
Tira depì on pelo de mona che on paro de buò.
Tra i pessi on bel ronbeto, tra i quadrupedi el porcheto.
Tri ani dura on sieve *, tri sieve dura on can, tri can dura on cavalo.
Tri mussi e on vilan fà quatro bestie.
Trista chela bestia che no para via le mosche co’ la so coa.
Troti de musso e salti de vecio dura poco.
Va’ in leto co le galine e lèvate quando che canta el galo.
Vale depì on gran de pévaro che on stronzo de musso.
Vàrdate dal culo del mulo, dal dente del can e da chi che tien la corona in man.
Vàrdate dala volpe e dal tasso e da chi che varda in basso.
Xe mèjo on musso vivo che on dotore morto.
Xe on bravo can el can che furfa par elo.
Xe pì fadiga far la guardia a na fémena che a on saco de polde
Numero Proverbi: 209
CAN: PROVERBI PAR …L’AMIGO
Ai can magri ghe va drio le mosche.
Can che baja no mòrsega.
Can no magna can.
Chi vol stare san pissa spesso come on can.
Chi vole el can se lo ciapa par la coa.
Co’ ‘l lovo deventa vecio i can ghe pissa incoste.
Col pan se fà balare i can.
Daighe a chel can che’l xe rabioso.
Dime ludro, dime can, ma no dirme furlan.
Done, cani e bacalà no i xe boni se no i xe pestà.
El can de du paruni more de fame.
I cojuni del can e i schei del vilan i xe i primi mostrà.
Na serenada de note dura fin che on can fà le balote.
Na volta core el lièvore, na volta core el can.
No tocare can che ròsega e zugadore che perde.
Nose e pan, magnare da can.
Ogni can mena la coa, ogni mona vol dire la soa.
On lièvore fra du can, on contadin fra du avocati, on malà fra du doturi: chi sta pèzo de luri!
Tanti can mazza on lovo* e on solo can baja a la luna. *( lupo)
Tri ani dura on sieve *, tri sieve dura on can, tri can dura on cavalo. * (siepe)
Xe on bravo can el can che furfa par elo.
Numero Proverbi: 21
CAMPI: I PROVERBI XE NATI IN CANPAGNA!
A chi che no vole far fadighe, el teren ghe produse ortighe.
A la botega, vaghe; a la canpagna, staghe.
A la luna de Setenbre la ua e el figo pende.
A San Baldoin se fa el vin.
A San Benedeto la vegna su par el paleto.
A San Bernardin fiorisse el lin. (20/5)
A San Bonaventura el medare* l’è finio in pianura. (15/7) * (mietitura)
A San Bovo se ronpe el primo ovo. (2/1)
A San Crispin se pesta el vin.(25/10)
A San Firmin, sòmena el contadin. (11/10)
A San Martin casca le foje e se beve el bon vin.
A San Martin el mosto deventa vin.
A San Martin se spina el bon vin.
A San Pelegrin, poca paja e poco vin. (5/5)
A San Roco le nose le va in scroco.(16/8)
A San Simon se cava la rava e ‘l ravanon.(28/10)
A San Vio le zarese le ga el marìo.
A San Zen, somenza in sen.(12/4)
A Sant’Ana le nose va in tana.
A Sant’Erman le arte* in man. (8/2) * (attrezzi da lavoro)
A Sant’Isaco, el formento fora dal saco.(19/10)
A Sant’Urban el formento el fa el gran.
A Santa ‘Fema, se scumizia la vendema.(s. Eufemia, 16/9)
A Santa Crose, pan e nose.(14/9)
A Santa Fiorenza xe oncora bona la somenza. (27/10)
A Santa Madalena la nosa xe piena.(22/7)
A Santa Madalena se taja l’avena.
A Santa Pologna la tera perde la rogna. (9/2)
A Santa Toscana el riso el va in cana. (14/7)
A Setenbre se destaca tuto quel che pende.
A somenare col vento se perde la somenza.
Agosto conpisse, Setenbre madurisse.
Agosto madura, Setenbre vendema.
Ai Morti e ai Santi i corvi sbandona i monti e i vien a pascolare ai canpi.
Aprile la spiga, Majo el late, Giugno el gran.
Aprile sparesin, Majo saresin.
Aprile tenperà e Majo suto, formento dapartuto.
Aqua de Agosto, miele e mosto.
Aqua de Aprile, fromento sol barile.
Aqua setenbrina, velen par la cantina.
Ara tanto e sòmena poco.
Bon come l’aqua de Lujo.
Canpo pestà no produse erba.
Cao curto vendema longa.
Cava erba e miti merda.
Chi ara fondo guadagna on mondo.
Chi che ga na vacheta ga na botegheta.
Chi che pianta de Aprile cava de Majo.
Chi desfa bosco e desfa pra se fà dano e no lo sa.
Chi dòpara loame no ga mai fame.
Chi ga canpi canpa.
Chi vol fare mosto zapa la tera de Agosto.
Chi vole on bel ajàro lo pianta de Zenàro.
Co’ canta el ciò xe finio de far filò.
Co’ canta el galo sola rosà, core l’aqua par la carezà.
Co’ canta le zigàle de Setenbre no conprare gran.
Co’ riva le Madone tute le zuche le xe bone.
Co’ te nassi scarognà, te scanpi dal musso e la vaca te tra.
Co’ xe soleselo ghe n’emo on brazelo.
Co’l fromento tra a l’anguro, tàjelo che’l xe maduro.
Co’l gran se incurva el contadin se indriza.
Da la Befana la rapa xe vana.
Da San Giorgio se sòmena l’orzo. (23/4)
Da San Marco la vigna buta l’arco.(25/4)
Da San Matio ogni fruto xe bonio.
Da San Valentin guerna l’ortesin. (14/2)
De Giugno miti la messora* in pugno. * (falce)
De San Luca pianta la rapa e cava la zuca.
De San Piero el formento e anca el pero.
De Sant’Antonio el formento indora.
De Sant’Urban la segala conpisse el gran.
De Santa Giustina tuta la ua xe marzemina.
Del Pardon (d’Assisi) se trà la zapa in t’on canton.
Dopo la crose na pèrtega par le nose.
Dove che comada le done e ara le vache, se vede robe mal fate.
Dove che ghe xe canpagne ghe xe putane.
Dura depì i loamari che i pajari.
El loame de cavalo el fruta on ano e no sò qualo.
El primo de Aprile, miti le zuche che le vien come on barile.
Fevraro curto, erba da par tuto.
Fin dai Santi sómena i canpi.
Fongo de Majo, spighe de Agosto.
Formento butà, paron in piè.
Gran fredo de Jenaro se incolma el granaro.
I canpi no vien mai veci.
I nostri veci ga magnà i canpi e i ne ga assà i proverbi.
Incalmà in onore de San Francesco, se no’l taca de verde el taca de seco.
Jenaro co la pòlvare, granaro de róare.
Jenaro suto, gran dapartuto.
L’ajo el xe la farmacia del vilan.
L’ajo guarisse el tajo.
L’aqua de Majo ingrassa el formento.
L’aqua de San Gregorio fà ranpegare la végna.
L’aria de Febraro xe come on loamaro.
L’orto xe mezo porco.
La boca la xe picola, ma la xe bona de magnare canpi e velada.
La piova de primavera ghe ronpe la rogna ala tera.
La piova de San Bernardin la roba pan, ojo e vin.
La pulizia va ben dapartuto, fora che in granaro.
La tera e i canpi li laora i ignoranti.
La tera xe mare e maregna.
Le canpane de San Martin vèrze le porte al vin.
Legna de fasso presto te vedo e presto te lasso.
Loame de porco no loama né canpo, né orto.
Loame, rivai e cavedagne, benedission dele canpagne.
Lujo in tana, se piove la xe na mana.
Majo fresco e ventoso fà l’ano copioso.
Majo fresco, fava e formento.
Majo fresco, paja e formento.
Majo ortolan, tanta paja e poco gran.
Majo piovoso, vin costoso.
Majo suto, gran dapartuto.
Marzo spolvarento, poca paja e tanto formento.
Marzo suto e Aprile bagnà: beato chel contadin che ga somenà.
Marzo sventolaro fromento in granaro.
Marzo sventolon, more la piègora e anca el molton.
Mèjo paron de on canpo che fituale de na canpagna.
Merda e aqua santa fà la racolta tanta.
Na bona aqua de Febraro vale pì de on loamaro.
Né zarese, né galete in granaro no se mete.
Neve de Jenaro inpina el granaro.
Nuvole in montagna no bagna la canpagna.
Par el seco xe bona anca la tenpesta.
Par i Santi, neve sui canpi; par i Morti, neve sui orti.
Par l’Anunziata la zuca xe nata.
Par San Domin sómena el contadin.
Par San Gioachin, l’ortolan nel camarin.
Par San Lorenzo la nosa xe fata.
Par Sant’Antonin, poca paja e poco vin.
Par Santa Cristina se sòmena la sajina.
Par Santa Fiorenza xe oncora bona la somenza.
Par Santa Pologna la tera la perde la rogna.
Par Santa Taresa prepara la tesa.
Pasqua vegna quando se voia, la vien co la frasca e co la foia.
Piova de Zenàro, erba de Febraro.
Pólvare de. Zenàro la inpina el granaro.
Quando che’l sorgo rosso el mostra el muso, xe ora de tore la roca e el fuso.
Quando la canavera fà el penacio, tanta neve e tanto jazzo.
Quando le nuvole va in montagna, ciapa la zapa e va in canpagna.
Quando se travasa se beve.
Quando xe ciara la marina, magna, bivi e va in cusina.
Quando xe ciara la montagna, magna, bivi e va in canpagna.
Quel che Lujo no vole, Setenbre no pole.
Ramo curto vendema longa.
San Paolo ciaro inpinisse el granaro. (25/1)
San Paolo San Paolon, tote su la scala e va a bruscare el vegnon.
San Valentin dal fredo fin, l’erba la mete el dentin.(14/2)
Sant’Antonin el vien lezièro: ormai semo ale asse sia in stala che in granaro. (10/5)
Sant’Antonio del paneto el vien col segheto. (13/6)
Schei, poderi e canpi e na bela coa davanti.
Se ‘l dì de San Martin el sole se insaca, vendi el pan e tote la vaca; Se ‘l va zo seren, vendi la vaca e tiente el fen.(11/11)
Se el primo tenporale el se sente a vale, bon ano senza tonpesta; se da monte a matina, on ano de ruina; se tona a mezodì o sera, bon ano se spera; se ‘l primo ton vien dal mantovan, vale pi el saco del pan.
Se fà belo a San Gorgon la vendema va benon.
Se Febraro no verdéga in Aprile no se sega.
Se Giugno sguaza poco vin in taza.
Se la luna fa on gran ciaro, poco fromento e tanto pajaro.
Se la luna xe in colore el canego more.
Se Majo fà fresco va ben la fava e anca el formento.
Se Majo rasserena, ogni spiga sarà piena.Se Marzo buta erba Aprile buta merda.
Se Marzo no incodega, a Majo no se sega.
Se Marzo resenta, fromento e polenta.
Se Nadale vien senza luna, chi ga do vache se ne magna una.
Se no piove so l’olivela piove so la brazadela.
Se par Setenbre no te ghe arà, tuto l’ano xe malandà.
Se piove a Pentecoste, tute le entrate no le xe nostre.
Se piove a San Bàrnaba la ua bianca la va via; se piove da matina a sera, va via la bianca e anca la nera. (11/6)
Se piove a San Giorgio ghe sarà carestia de fighi.(23/4)
Se piove a San Vito e Modesto, la ua va torla col zesto.(15/6)
Se piove a Sant’Ana, la xe na mana.
Se piove a Sant’Urban ogni spiga perde on gran.
Se piove a Santa Desiderata, casca la ua e resta la grata. (14/6)
Se piove ai primi de Majo, nose e fighi fà bon viajo.
Se piove da la Madona, la xe oncora bona.
Se piove de San Duane, fen e paja deventa loame.
Se piove par San Vio al vin còreghe drio.
Se piove sui cavajuni, bondanza de galine e ovi.
Soto la neve, pan; soto l’aqua, paltan.
Stajon de erba, stajon de merda.
Stimar la roba in erba l’è on stimar de merda.
Stropa longa, inverno longo; stropa curta, inverno curto.
Tenpo e paja fà fare i néspoli.
Tera negra fà bon fruto, tera bianca guasta tuto.
Uno no fà canpion.
Voja o no voja, Pasqua fà foja.
Zuche e fen int’on mese i vien.
Numero Proverbi: 185
CORPO: EL CORPO FATO A …TOCHI DAI PROVERBI
A chi carne de testa e a chi de colo.
A ogni culo el so cagare.
A San Nicòlo tira la neve sol colo.(6/12)
A sentarse so do careghe el culo se sbrega.
Anca l’ocio vole la so parte.
Bisogna avere oci anca sol culo.
Bisogna menare el dente conforme che uno se sente.
Boca onta no la pole dire de no.
Boca sarà no ciapa moschini.
Bon naso, fà bel’omo.
Chi che se marida de carnevale slonga le ganbe e scurza le bale.
Chi no ga testa ga ganbe.
Chi sbaglia de testa paga de scarsela.
Chi se taja el naso se insànguena la boca.
Chi vol fare el stronzo massa grosso ghe vien le làgreme ai oci.
Chi vole ‘ndare massa in suso, casca par tera e se ronpe el muso.
Co l’età, l’omo fa panza e la fémena fa stomego.
Co la panza piena se rajona mèjo.
Co’ bala l’ocio drito, cuor contrito; co’ bala l’ocio zanco, cuore infranto.
Co’ i zenoci se ama le caece no se pol vèdare.
Co’ la carne xe frusta l’ànema deventa justa.
Co’ la oja la xe pronta le ganbe se fà liziere.
Corpo pien ànema consolà.
Dio te varda dal vermo del fenocio e da chi che ga on solo ocio.
Dopo i …anta ganbe che trèmola, tete che scanpa.
El naso gusta e la boca patisse.
El vilan xe largo de boca e streto de man.
Gnente, xe bon pa’i oci.
I morti verze i oci ai vivi.
I oci del spazacamin xe senpre bianchi.
L’onbra d’istà fà male ala panza d’inverno.
La boca e el culo xe fradei.
La boca la se liga solo ai sachi.
La boca la xe picola, ma la xe bona de magnare canpi e velada.
La boca no xe straca se prima no la sa de vaca.
La fémena xe come on falzin: batarla ogni tanto, guzarla senpre.
La lengua bate dove che’l dente duole.
La léngoa no ga osso, ma la pole rónpare i ossi.
La piègora xe benedeta dal culo e maledeta dala boca.
La roba che se buta via coi piè, vien dì che la se rancura co le man.
La roba donà fà male ala panza.
Le parole no inpinisse la panza.
Mal de testa vole magnare, mal de panza vole cagare.
Na man lava l’altra e tute do lava el muso.
Né a l’ocio, né a l’ongia no ghe vole gnente che sponcia.
Né na parola dita, né on naso tirà no torna indrio.
Né panza, né rogna, né tosse se sconde.
No fare el passo pì longo del ganba.
Oci e lengua xe le spie de tante malatie.
Oci mori, rubacuori; oci bisi, paradisi; oci celeste fà inamorare; oci bianchi fà cagare.
Ocio celeste, ocio de dama; ocio moro, ocio da putana.
Ocio no vede e boca tase par chi che vol vìvare in pase.
Ocio no vede, cuore no sente.
On baso, na forbìa: el baso xe nda via.
On ocio ala gata e staltro ala paèla.
Panza piena vole riposo.
Panza voda camisa tacà.
Par San Damàso el fredo al toca el naso.
Parenti mal de denti.
Pì in alto se va e pì se mostra el culo.
Pitosto che roba vanza, crepa panza.
Polenta brustolà la smorza el figà.
Quatro oci vede pì de du.
Rosso de pelo, zento diavoli par cavejo.
Se fà spira la man drita, schei da dare; se fà spira la man zanca, schei da tirare.
Tanti paìsi e tante usanze, tante teste e tante panze.
Testa de musso no se pela mai.
Tronba de culo, sanità de corpo.
Tute le scarpe no va ben ‘ntel stesso piè.
Tuto se justa, fora che l’osso del colo.
Vardarse da quei che parla coi oci bassi e da quei che ride senpre.
Veleta e capelo fà el viso belo.
Via el dente, via el dolore.
Xe inutile fermare el treno col culo.
Xe mejo avere sete busi in testa che sete piati de minestra.
Xe mèjo cavarse on ocio che magnare el vermo del fenocio.
Xe mèjo sbrissare co’ i piè che co la lengua.
Xe par la boca che se scalda el forno.
Numero Proverbi: 78
DOTTORI: I PROVERBI NO SE FIDA D’I DOTURI…
I proverbi no se fida d’i doturi…
Chi beve prima dela minestra, vede el mèdego dala finestra.
Chi vole stare san dai mèdeghi staga lontan.
Davanti al prete, al dotore e a on capitelo càvate senpre el capelo.
Dotori e preti no dà mai gnente a nissun.
El mèdego pietoso fà la piaga verminosa.
Falo de mèdego, volontà de Dio.
Fin che’l mèdego pensa el malà muore.
Fra i doturi, in medesina, xe pì bravo chi indovina.
I fali, el médego li sconde la tera.
I mèdeghi e le patate ga i fruti soto tera.
L’amigo del prete perde la relijon, l’amigo del dotore perde la salute, l’amigo del’avocato perde la causa.
Mèdeghi e guera spopola la tera.
Mèdego vecio e chirurgo zòvane.
Mèjo on àseno vivo che on dotore morto.
On lièvore fra du can, on contadin fra du avocati, on malà fra du doturi: chi sta pèzo de luri!
Prete, dotore e comare, no te ne ingatejare.
Xe mèjo on musso vivo che on dotore morto.
Numero Proverbi: 17
FEMENE: Qua se parla de fémene
A ‘la Salute se veste le bele pute.(21/11)
Al ciaro de na candela no se stima né dona né tela.
Al son de la canpana (schei) ogni dona se fa putana.
Al vento e ale done no se comanda.
Ala de capon, culo de castron e tete de massara xe na roba rara.
Ala dona no se dise né bruta, né vecia.
Ale done, ai sassi e ai bissi, colpi ciari e fissi.
Assa che la mojère la comanda in casa: solo cussì la te struca e la te basa.
Beata chela sposa che la prima che la ga la sia na tosa.
Bela in fassa, bruta in piaza.
Bruta de muso, larga de buso.
Casa neta, dona regina.
Caval bianco e bela mojèr dà senpre pensièr.
Che la piasa, che la tasa e che la staga in casa.
Chi che ga na bela mojère no la xe tuta soa.
Chi che zerca cavalo e fémena senza difeto, no’l gavarà mai cavalo in stala e fémena in leto.
Chi co done va e mussi mena, i crede de rivare a disnare e no i riva gnanca a zena.
Chi dise dona dise dano.
Chi dise sposa dise spesa.
Chi vole el pomo sbassa la rama, chi vole la tosa careza la mama.
Co l’età, l’omo fa panza e la fémena fa stomego.
Co le done e co le merde se barufa e po’ se perde.
Co’ nasse na fémena, nasse na serva; co’ nasse on omo, nasse on paron.
Co’ parla na bela dona la ga senpre rason.
Co’l cavéjo tra al bianchin, assa la dona e tiente el vin.
Cusina che fuma, dona cativa e coverta rota manda l’omo in malora de troto.
De nose on saco, ma no pì de na fémena par casa.
Do fémene fà on marcà.
Dona bela e vin bon xe i primi che te assa in abandon.
Dona de mondo no ga mai fondo.
Dona e luna, ora serena ora bruna.
Dona nana, tuta tana.
Dona sconpagnà xe senpre mal vardà.
Done, cani e bacalà no i xe boni se no i xe pestà.
Done e afani scurza i ani.
Dove che comanda le done e ara le vache se vede robe mal fate.
El naso d’i gati, i zenoci d’i òmani e ‘l culo dele fémene xe senpre fridi.
El primo ano se ghe vole tanto ben che la se magnaria, el secondo se se ciama grami de no verla magnà.
El segreto dele femene no lo sa nissun, altro che mi, vu e tuto el comun.
Fà la corte ale vecie se te vo’ piasérghe ale zòvane.
Fin che na bela xe vardà, na bruta xe maridà.
Fumo e dona ciacolona fà scanpare l’omo de casa.
Ghe vole sete fémene par fare on testimonio.
Giugno, Lujo e Agosto, né dona, né aqua, né mosto.
I òmani ga i ani ch’i se sente, le done quei che le mostra.
In istà la vache va in montagna a fare le siore, e le siore va in montagna a fare le vache.
L’omo el tien su on canton dela casa, la fémena staltri tri.
L’omo fà la dona e la dona fà l’omo.
La bona mojère fà el bon marìo.
La dona xe come la castagna: bela de fora, dentro la magagna.
La dona va sojeta a quatro malatie al’ano e ogni una dura tri misi.
La fémena xe come l’aqua santa: tanto fà poca come tanta.
La fémena xe come on falzin: batarla ogni tanto, guzarla senpre.
La mojere xe come na scoreza: o ti ’a moli o ti ’a sòfeghi.
La prima fachina, la seconda regina.
La prima xe matrimonio, la seconda xe conpagnia, la terza na eresia.
Le done xe sante in cèsa, angeli in strada, diavoli in casa, zoéte sol balcon, gaze so la porta.
Le femene, co’ le se confessa le dise senpre quelo che no le ga fato.
Le fémene no sa de èssare sentà dessora ala so fortuna.
Le tose lo desidera, le maridà lo prova, le vedove lo ricorda.
Leto fato e fémena petenà, la casa xe destrigà.
Libri, done e cavai no se inpresta mai.
Lìssia e pan: dale done staghe lontan.
Mèjo na dona bela senza camisa che na bruta co sete camise.
Na dona stenta a dirghe bela a ‘nantra.
Na dona bela pole zernìre, la bruta tole su a fato.
Na fèmena pianta e despianta na fameja.
No se pole avere la bota piena e la mojère inbriaga.
Nose e done no se sa quale che sia bone.
Ocio celeste, ocio de dama; ocio moro, ocio da putana.
Ogni fémena xe casta se no la ga chi la cazza.
On palo in piè, na stropa domà e na fémena colgà i porta quanto peso che te voi.
Ovo de on’ora, pan de on dì, vin de on ano, dona de quìndese e amigo de trenta.
Pan e nose xe on magnare da spose.
Pan e nosele magnar da putele.
Pan padovan, vini visentini, tripe trevisane e done veneziane.
Parché la dona sia perfeta la ga da vére 4 ‘M': matrona in strada, modesta in cèsa, massara in casa, mata in leto.
Pèto picenin, late pegorin.
Piola al balo, grande a cavalo.
Quando la mojère se mete le braghesse, al marìo no ghe resta che le còtole.
Quando la dona trà l’anca, o la xe vaca o poco ghe manca.
Quando le done fa la lissia sola via, l’inverno sbrissa via.
Rossa de pelo, mata par l’osèlo.
Sa volì conossare na persona, vardè la dona al balo e l’omo al zogo.
Se i dise male de to fiola, ciama la comare.
Se na dona xe bela, partorisse na putela.
Sete òmani no mena drento col caro quanto che na fémena la porta fora co la traversa.
Tèndare le tose e bàtare le nose xe tenpo perso.
Tenpo, done e siuri i fà come che i vole luri.
Tre fémene? Una viva, una morta, una inpiturìa de drio la porta.
Vàrdate da l’omo che porta el recin e dala dona che sa de latin.
Vin vecio e dona zòvane.
Vin, done e maroni bisogna gòdarli so’ la so stajon.
Xe pì fadiga far la guardia a na fémena che a on saco de polde
Xe pì le done che varda i òmani che le stele che varda la tera.
Numero Proverbi: 95
FIOI: I FIOI VISTI DAI NOSTRI VECI
A tusi e mati no se comanda.
Chi che ga solo on porzelo lo ga belo, chi ga solo on tosato lo ga mato.
Chi ghe n’a in cuna no diga de nissuna.
Chi nasse de Lujo no speta comare.
Conpare de anelo pare del primo putelo.
Costa depì on vizio che diese fioi.
De San Martin se sposa la fiola del contadin.
El pare fà la roba, i fioi la vende.
Fioi da slevàre, fero da rosegare.
Fioi picoli, pensieri picoli; fioi grandi, pensieri grandi.
I fioi no porta carestia.
I fioi vien dal cuore, el marìo dala porta.
Mèjo du vivi (fioi) che uno morto.
Mèjo fare on toso che fare na polenta.
Mèjo piànzarli morti inocenti che vivi delinquenti.
On pare mantien sete fioi, sete fioi no xe boni de mantegnere on pare.
Pare che guadagna, fioi che magna.
Quando che’l pitoco mete le braghe sol leto ghe nasse on fiolo.
Rechie-meterna, chi che li ga fati se li guerna.
Se i dise male de to fiola, ciama la comare.
Tèndare le tose e bàtare le nose xe tenpo perso.
Tuti semo fioi de Adamo.
Numero Proverbi sora l’argomento: 22
FRUTI: I FRUTI SE RANCURA ANCA CO I PROVERBI
A la luna de Setenbre la ua e el figo pende.
A San Martin, castagne e vin.
A San Roco le nose le va in scroco.(16/8)
A San Vio le zarese le ga el marìo.
A Sant’Ana le nose va in tana.
A Santa ‘Fema, se scumizia la vendema.(s. Eufemia, 16/9)
A Santa Crose, pan e nose.(14/9)
A Santa Madalena la nosa xe piena.(22/7)
A Setenbre se destaca tuto quel che pende.
A Setenbre, braghe de tela e moloni no i xe pì boni.
Agosto madura, Setenbre vendema.
Aprile sparesin, Majo saresin.
Chi vole el pomo sbassa la rama, chi vole la tosa careza la mama.
Da San Matio ogni fruto xe bonio.
De nose on saco, ma no pì de na fémena par casa.
De San Piero el formento e anca el pero.
De Santa Giustina tuta la ua xe marzemina.
Dopo la crose na pèrtega par le nose.
El bon figo ga da vere camisa da pitoco, colo da picà e culo da pescadore.
El fruto no’l casca mai lontan da l’àlbaro.
El pèrsego col vin, el figo co l’aqua.
El vilan el vendarìa el gaban par formajo, piri e pan.
Fighi e ùa, el culo se frùa.
Fiuri e fruti se pol tore da tuti.
I mèdeghi e le patate ga i fruti soto tera.
La casa no fà fighi.
La dona xe come la castagna: bela de fora, dentro la magagna.
La zaresa pi bona la xe quela del merlo.
Maroni e vin novo, culo mio te provo.
Maroni e vin novo, scoreze de fogo.
Né zarese, né galete in granaro no se mete.
No ghe xe farina senza sémola, nosèla senza scorza, gran senza paja e omo senza difeti.
Nose e done no se sa quale che sia bone.
Nose e pan, magnare da can.
Nose e pan, pasto da vilan.
On pomo de matina te cava el cataro e te fa pissare ciaro.
Pan e nose xe on magnare da spose.
Pan e nosele magnar da putele.
Par San Lorenzo la nosa xe fata.
Pèrsego e melon tuto ala so’ stajon.
Quando che te magni la nèspola, pianzi.
Quando che’l vin no xe pì mosto, la castagna xe bona a rosto.
Quando piove par la Crose, bon el gran, triste le nose.
Se piove a San Bàrnaba la ua bianca la va via; se piove da matina a sera, va via la bianca e anca la nera. (11/6)
Se piove a San Giorgio ghe sarà carestia de fighi.(23/4)
Se piove a San Vito e Modesto, la ua va torla col zesto.(15/6)
Se piove a Santa Desiderata, casca la ua e resta la grata. (14/6)
Se piove ai primi de Majo, nose e fighi fà bon viajo.
Se piove el dì de Santa Crose el fà cascare le nose.
Se’l tona el dì de San Duane, le cuche va sbuse e le nosèle vane. (24/6)
Tante nosèle, tanta neve.
Tèndare le tose e bàtare le nose xe tenpo perso.
Tenpo e paja fà fare i néspoli.
Vin, done e maroni bisogna gòdarli so’ la so stajon.
Numero Proverbi: 54
GATI: EL GATO GHE ENTRA SENPRE!
Al mese de Jenaro la gata va in gataro.
Chi sparagna el gato magna.
Co’l sorze scanpa, la gata va al paese.
De Febraro ogni gata va in gataro.
El gato sol fogolaro xe segno de miseria.
El naso d’i gati, i zenoci d’i òmani e ‘l culo dele fémene xe senpre fridi.
Gato sarà deventa leon.
Mèjo on sorze in boca a on gato che on omo par le man de on avocato.
No xe colpa dela gata se la parona la xe mata.
On ocio ala gata e staltro ala paèla.
On omo in man del’avocato xe come on sorze in boca al gato.
Quando ch’el gato dorme i sorzi bala.
Tien on ocio al pesse e ‘nantro al gato.
Numero Proverbi: 13
INVERNO: EL POSTO DEL’INVERNO SUI PROVERBI
A l’Imacolata se scumizia l’invernata.
A San Clemente l’inverno mete el dente.(23/11)
Candelora, de l’inverno semo fora.
Cativo inverno, cativo istà.
Chi no sa cossa che xe l’inferno, fassa el cogo d’istà e ‘l caretier d’inverno.
Co l’Adolorata se va verso l’invernata.
Co’ névega sola foja l’è on inverno che fa oja.
De istà ogni beco fà late, de inverno gnanca le bone vache.
I dì dela merla l’inverno te dà na sberla.
I du Santi del giazo: San Luigino e San Paolino i porta l’Inverno de Giugno.
L’inverno l’è el boia di’ veci, el purgatorio di’ putei e l’inferno di’ poariti.
L’onbra d’istà fà male ala panza d’inverno.
Né de inverno, né de istà tabaro e onbrela mai a ca’.
O dal cao o dala coa l’inverno vol dire la soa.
Pan, vin e zoca, lassa pur che’l fioca.
Piove pì àneme al’inferno che neve de inverno.
Primo de Agosto, capo de inverno.
Quando che’l sorgo rosso el mostra el muso, xe ora de tore la roca e el fuso.
Quando le done fa la lissia sola via, l’inverno sbrissa via.
Stropa longa, inverno longo; stropa curta, inverno curto.
Numero Proverbi: 20
ISTA’: L’ISTÀ SUI PROVERBI
A l’istà piove a contrà.
Agosto cola el pionbo.
Beato l’Istà co tuti i pulzi e i zìmesi che’l ga.
Cativo inverno, cativo istà.
Chi no sa cossa che xe l’inferno, fassa el cogo d’istà e ‘l caretier d’inverno.
De istà ogni beco fà late, de inverno gnanca le bone vache.
Febraro inevà fà bela l’istà.
Fin a Nadale fredo no fà: braghe da istà; dopo Nadale el fredo xe passà, braghe da istà.
In istà la vache va in montagna a fare le siore, e le siore va in montagna a fare le vache.
L’istà de San Martin dura tri dì e on pochetin.
L’onbra d’istà fà male ala panza d’inverno.
Né de inverno, né de istà tabaro e onbrela mai a ca’.
Par San Barnabà el dì pì longo de l’Istà.
Piova d’Istà, beati che che la ga.
Numero Proverbi: 14
MAGNARE: I PROVERBI A TOLA O TORNO LÌ.
A chi che no ghe piase el vin , che Dio ghe toga anca l’aqua.
A magnare el zervelo del pesse se deventa intelijente.
A magnare on spigo de ajo, se spuza come a magnarghene na resta.
A San Martin, castagne e vin.
A Santa Crose, pan e nose.(14/9)
A tola e leto no se porta rispeto.
A tola no se vien veci.
Al primo de Agosto l’ànara se mote a ‘rosto.
Ala de capon, culo de castron e tete de massara xe na roba rara.
Bacalà a ‘la visentina, bon se sera e de matina.
Barbi e rane mai de Majo, parché i fa tristo passajo.
Bieta e vin juta el segantin.
Carne de vaca e legno de figaro par far bela ziera al’amigo caro.
Carne zòvane e pesse vecio.
Chi che laora magna, chi che no laora magna e beve.
Chi che magna aloè vive i ani de Noè.
Chi che no ga fame, o l’è malà o’l ga magnà.
Chi che xe vizin ala cusina magna minestra calda.
Chi fida nel loto no magna de coto.
Chi magna carpion no xe on babion.
Chi magna salata fà la vita beata.
Chi no ghe piase galina col pien, merita pache opure velen.
Chi no magna ga magnà.
Chi vol magnare on bon bocon, magna l’oca col scoton.
Co la panza piena se rajona mèjo.
Co’ riva el trenta de Agosto tute le zuche le va ‘rosto.
Co’ se guadagna se magna.
Corpo pien ànema consolà.
De Otobre, on bel oveto xe pì dolze de on confeto.
De pesse scanpà no se ne ga mai magnà.
Del pito el passo, del polo el volo.
Dio te varda da on magnadore che no beve.
El bon formajo se fà de majo.
El bòvolo xe on pasto fin: bon par el vecio, bon par el putin.
El capon xe senpre de stajon.
El fogo juta el cogo.
El lardo vecio conza la minestra.
El magnare d’i poariti l’è in bisaca ai siuri.
El malà no magna gnente e ‘l magna tuto.
El naso gusta e la boca patisse.
El pan del mona xe el primo magnà.
El pèrsego col vin, el figo co l’aqua.
El pesse ga da noare tre volte: prima ‘ntel’aqua, dopo ‘ntel’ojo e la terza ‘ntel vin.
El pesse guasta l’aqua, la carne la conza.
El riso nasse da l’aqua e ‘l ga da morire sol vin.
El simile col simile, ma le verze co l’ojo.
El vilan el vendarìa el gaban par formajo, piri e pan.
Erba crua no xe par testa canua.
Fighi e ùa, el culo se frùa.
Fin a Nadale magnemo verze e rave.
Formajo, pan bianco e vin puro fà el polso duro.
Galina vecia fà bon brodo.
Ghe xe chi che magna le fave e chi che magna le sgusse.
Ghe xe pì dì che luganega.
I fasoi xe la carne di’ poariti.
I nostri veci ga magnà i canpi e i ne ga assà i proverbi.
I nostri veci ga magnà i capuni e i ne ga assà i proverbi.
In amore nasse corajo se te magni del formajo.
L’ovo del luni pagan l’è del diavolo.
La boca la xe picola, ma la xe bona de magnare canpi e velada.
La boca no xe straca se prima no la sà de vaca.
La coéga cola sol lardo.
La menestra xe la biava de l’omo.
La panza d’i preti xe el zimitero d’i capuni.
La salata la vole el sale da on sapiente, l’aseo da on avaro, l’ojo da on prodigo, smissià da on mato e magnà da on afamà.
La testa del barbon xe el mejo bocon.
Magari polenta e pessin, ma na bela testa sol cussin.
Magna da san e bivi da malà.
Magnà i gànbari se ciucia anca le zate.
Magna renghe e sardeloni: te conservarè i polmoni.
Magna, bivi e godi, ma no inpiantare ciodi.
Mal de testa vole magnare, mal de panza vole cagare.
Maroni e vin novo, scoreze de fogo.
Marsoni friti e polentina, on fià de vézena e vin de spina.
Mèjo on ovo oncuò che na galina doman.
Mese de Agosto, colonbo rosto.
Minestra rescaldà no xe mai bona.
Nadale col mandolato, i Morti co la fava, Pasqua co la fugazza.
Né re, né disnare no se fà mai spetare.
No bisogna magnare i ovi prima de verghe cavà la sgussa.
No ghe xe gnente de pì bon che el colo del capon.
Nose e pan, magnare da can.
Nose e pan, pasto da vilan.
O de paja o de fe, cogna che’l stómego sia pien.
Pan che canta, vin che salta e formajo che pianza.
Pan e nose xe on magnare da spose.
Pan e nosele, magnar da putele.
Pan fin che’l dura, vin a misura.
Pan padovan, vini visentini, tripe trevisane e done veneziane.
Pan, sopressa e conpagnia su ‘nte’l bosco fà alegria.
Panza piena vole riposo.
Panza voda camisa tacà.
Pitosto che roba vanza, crepa panza.
Polenta brustolà la smorza el figà
Polenta e late ingrossa le culate.
Polenta e puina, pì che se core, manco se camina.
Polenta nova e osei de riva, vin de grota e zente viva.
Polenta senza sale, ma on bel viseto sol cavazale.
Priego a magnare, priego a laorare.
Puina* in ponta, formajo in crosta e salame in coa. *(ricotta)
Quando a Novenbre el vin no xe pì mosto, la pitona xe pronta par el ‘rosto.
Quando che la spiga ponze, la sardela onze.
Quando che te magni la nèspola, pianzi.
Quando che’l vin no xe pì mosto, la castagna xe bona a rosto.
Quando la rosa buta el spin, magna gò e passarin.
Quando xe ciara la marina, magna, bivi e va in cusina.
Quando xe ciara la montagna, magna, bivi e va in canpagna.
Quatro a on segon, du a on capon.
Quelo che no sòfega ingrassa.
Quelo che no strangola ingrassa e quelo che no ingrassa passa.
Risi bianchi, magnare da béchi.
Sa volì védare el diluvio universale, metì dodese preti a tola a magnare.
San Bogo, la torta al fogo.
Tenca de Majo e luzo de Setenbre.
Tra i pessi on bel ronbeto, tra i quadrupedi el porcheto.
Tripe de merda parché l’osto no ghe perda.
Vin de fiasco: ala sera bon, ala matina guasto.
Xe mèjo cavarse on ocio che magnare el vermo del fenocio.
Xe mèjo èssare bechi e ver da becare che no èssare bechi e no ver da magnare.
Xe mèjo polenta in casa soa che rosto in casa di’ altri.
Xe par la boca che se scalda el forno.
Zena longa, vita curta; zena curta, vita longa.
Zuca santa che la canta e baruca che la sia muta.
Numero Proverbi sol’argomento: 123
MALATIE: SORA LE MALATIE E I MALANI.
A dieta el mal se chieta.
Amore, tosse e panza no se sconde.
Aria de fessura porta ala sepoltura.
Chi che grata la rogna ai altri rinfresca la soa.
Chi che no ga fame, o l’è malà o’l ga magnà.
Chi ladra, Dio ghe dona; chi no ladra, pioci e rogna.
Co’ la carne xe frusta l’ànema deventa justa.
Dolore confidà xe guarìo par metà.
El malà no magna gnente e ‘l magna tuto.
El male dela pria xe el pezo male che ghe sia.
El male no domanda permesso.
El male riva a cavalo e ‘l parte a piè.
El male vien a carete e ‘l va via a onze.
El mèdego pietoso fà la piaga verminosa.
In casa strinzi, in viajo spendi, in malatia spandi.
In tenpo de peste pì baje che feste.
L’ajo el xe la farmacia del vilan.
L’ajo guarisse el tàjo.
L’aqua de San Joani guarisse tuti i malani.
L’onbra d’istà fà male ala panza d’inverno.
La dona va sojeta a quatro malatie al’ano, e ogni una dura tri misi.
La roba donà fà male ala panza.
La rosà de Majo guarisse le buganze de genajo.
La tosse xe ‘l tanburo dela morte.
Magna da san e bivi da malà.
Mal de testa vole magnare, mal de panza vole cagare.
Né la malatia, né la preson fà deventare l’omo bon.
Né panza, né rogna, né tosse se sconde.
Oci e lengua xe le spie de tante malatie.
Parenti mal de denti.
Salute,amore, schei e tenpo par gòdarli.
Xe mèjo suàre che tossire.
Numero Proverbi sol’argomento: 32
MESI: A OGNI MESE I SO PROVERBI…
A Jenaro tuti i veci va a ponaro.
A la luna de Setenbre la ua e el figo pende.
A le prime aque de Agosto la tortora la va via.
A Marzo ogni mato va descalzo.
A Setenbre se destaca tuto quel che pende.
A Setenbre, braghe de tela e moloni no i xe pì boni.
A Setenbre, chi xe esperto no viaja mai descuerto.
Agosto cola el pionbo.
Agosto conpisse, Setenbre madurisse.
Agosto madura, Setenbre vendema.
Agosto rinfresca el bosco.
Ai ultimi de Setenbre, i fringuei par la tesa.
Al mese de Jenaro la gata va in gataro.
Al primo de Agosto l’ànara se mete a ‘rosto.
Ala Madona de Agosto rinfresca el bosco.(15/8).
Ala prima aqua de Agosto, pitoco te conosso.
Aprile ga el fiore, Majo l’odore.
Aprile la spiga, Majo el late, Giugno el gran.
Aprile piovoso, ano frutuoso.
Aprile tenperà e Majo suto, formento dapartuto.
Aprile, on’ora el pianze, on’ora el ride.
Aqua de Agosto, miele e mosto.
Aqua de Aprile, fromento sol barile.
Aqua setenbrina, velen par la cantina.
Aria setenbrina, fresca la sera fresca la matina.
Barbi e rane mai de Majo, parché i fa tristo passajo.
Beato l’Istà co tuti i pulzi e i zìmesi che’l ga.
Bon come l’aqua de Lujo.
Chi ghe ga on zoco sol cortile, lo tegna pa ‘l mese de Aprile.
Chi che pianta de Aprile cava de Majo.
Chi nasse de Lujo no speta comare.
Chi vole on bel ajàro lo pianta de Jenaro.
Co’ canta le zigàle de Setenbre no conprare gran.
Co’ riva el trenta de Agosto tute le zuche le va ‘rosto.
Co’ toneza de Jenaro chi ga quatro vache se ne magna on paro.
De Febraro calche mato va senza tabaro.
De Febraro ogni gata va in gataro.
De Giugno miti la messora* in pugno. *(falce)
De Marzo no bisognarìa che pissesse gnanca na rana.
De Novenbre, quando tona xe segnal de anata bona.
De Otobre, on bel oveto xe pì dolze de on confeto.
Dicenbre se tole e no rende.
Dicenbre, davanti el te scalda e de drio el te ofende.
El bon formajo se fà de majo.
El primo de Aprile, miti le zuche che le vien come on barile.
El sole de Agosto brusa i piantoni.
Febraro inevà fà bela l’istà.
Fevraro curto, erba da par tuto.
Fevraro curto, pezo de tuto.
Fongo de Majo, spighe de Agosto.
Giugno, Lujo e Agosto, né dona, né aqua, né mosto.
Gran fredo de Jenaro se incolma el granaro.
I du Santi del giazo: San Luigino e San Paolino i porta l’Inverno de Giugno.
I ùltimi de Jenaro, sèntate sol fogolaro.
Jenaro co la pòlvare, granaro de ròare.
Jenaro e Febraro i xe du misi che va a paro.
Jenaro suto, gran dapartuto.
L’aqua de Giugno ruina el munaro.
L’aqua de Majo ingrassa el formento.
L’aria de Febraro xe come on loamaro.
La neve decenbrina disisète volte la se capina.
Luna setenbrina sete lune se ghe inchina.
Luna setenbrina, sete lune la indovina.
Majo fresco e ventoso fà l’ano copioso.
Majo fresco, fava e formento.
Majo fresco, paja e formento.
Majo ortolan, tanta paja e poco gran.
Majo piovoso, vin costoso.
Majo suto, gran dapartuto.
Marzo el se fà vanti, el merlo el fà noze coi so canti.
Marzo spolvarento, poca paja e tanto formento.
Marzo suto e Aprile bagnà: beato chel contadin che ga somenà.
Marzo sventolaro fromento in granaro.
Marzo sventolon, more la piègora e anca el molton.
Marzo, par quanto tristo che’l sia, el buò al’erba e ‘l cavalo al’onbrìa.
Mese de Agosto, colonbo rosto.
Na bona aqua de Febraro vale pì de on loamaro.
Nela luna setenbrina la sardela se rafina.
Neve de Jenaro inpina el granaro.
Neve novenbrina trédese volte la se rafina.
No vien Majo se no fiorisse le rose.
Novenbre col ton, l’ano xe bon.
Novenbre e Dicenbre benedisse Setenbre.
Novenbre, co San Martin ano novo par el contadin.
Piova de Jenaro, erba de Febraro.
Pòlvare de Jenaro la inpina el granaro.
Primavera de Jenaro la ruina el persegaro.
Primo de Agosto, capo de inverno.
Quando a Novenbre el vin no xe pì mosto, la pitona xe pronta par el ‘rosto.
Quando a Otobre scurisse e tòna, l’invernada sarà bona.
Quando el merlo canta d’amore Febraro finisse.
Quel che Lujo no vole, Setenbre no pole.
Se Febraro no verdéga in Aprile no se sega.
Se Giugno sguaza poco vin in taza.
Se Jenaro no fà el giazo, Febraro fà el pajazo.
Se Majo fà fresco va ben la fava e anca el formento.
Se Majo rasserena, ogni spiga sarà piena.
Se Marzo buta erba Aprile buta merda.
Se Marzo no incodega, a Majo no se sega.
Se Marzo resenta, fromento e polenta.
Se no fa caldo a Lujo e Agosto sarà tristo el mosto.
Se Otobre camina lento te pol èssare contento.
Se par Setenbre no te ghe arà, tuto l’ano xe malandà.
Se piove ai primi de Majo, nose e fighi fà bon viajo.
Se vènta* ai tri de Marzo e al dì de San Gregorio, vènta par quaranta dì. (12/3)
Starna setenbrina, una la sera e una la matina.
Suta de Agosto, tonpesta de Majo.
Tenca de Majo e luzo de Setenbre.
Vento de Majo, poco tormento.
Numero Proverbi che parla de misi: 109
MESTIERI: TUTI I MESTIERI, SPECIE QUILI DE NA VOLTA
A canbiare munaro se canbia ladro.
A l’astuzia del munaro no gh’è mai nissun riparo.
A San Firmin, sòmena el contadin. (11/10)
Bieta e vin juta el segantin.
Botega de canton fà schei ogni cojon.
Chi arte no sà, botega sara.
Chi che fa el conto prima de l’osto el lo fa do volte.
Chi che ga on mistièro in man da par tuto trova pan.
Chi fà scarpe porta zavate.
Chi mistièro no sa botega sara.
Chi va a l’osto perde el posto.
Ciodo, martelo e segon: i miracoli del marangon*. *(falegname)
Co l’arte e co l’ingano se vive mezo ano; co l’ingano e co l’arte se vive staltra parte.
Co’ l’osto xe sola porta no ghe xe nissuni drento.
El bon figo ga da vere camisa da pitoco, colo da picà e culo da pescadore.
El fogo juta el cogo.
El laòro dela sega el slonga i brazi e ‘l scurza la tega.
El laòro fato de festa va fora par la finestra.
El marangon conosse el legno tristo e quelo bon.
El marangon laora senza stajon.
El marzaro*, prima el fà i schei e dopo la cossienza.
El moleta fà girare la rua, el cortelo intanto se frua.
El tenpo fà i mistieri.
Fare i mistieri che no se conosse i dìnari i deventa mosche.
I oci del spazacamin xe senpre bianchi.
In casa de pescaduri l’è on tristo pescare.
In t’el mistiero del munaro, tanto se roba co la stadiza che col staro.
L’aqua de Giugno ruina el munaro.
L’ortolan ga senpre tera in man.
L’ultimo che more de fame xe ‘l munaro.
La camisa del spazacamin xe senpre sporca.
La morte xe senpre pronta, come le tole dei osti.
La pignata de l’artesan, se no la boje oncuò la boje doman.
La sega misura el brazzo.
La tera e i canpi li laora i ignoranti.
La zeola la xe la rufiana del cuogo.
Laòro de manareto poco e maledeto.
Laòro de sachi laòro da mati.
Laòro tacà finìo par metà.
Le parole del moleta no le vale on’eta.
Luna bassa, pescadore sicuro.
Luna in piè, marinaro sentà; luna sentà, marinaro in piè.
Marcante e porco stimalo dopo morto.
Marzo suto e Aprile bagnà: beato chel contadin che ga somenà.
Mèjo on sorze in boca a on gato che on omo par le man de on avocato.
No bisogna domandarghe a l’osto se’l ga bon vin.
Novenbre, co San Martin ano novo par el contadin.
O tardi o bonora, l’osto va in malora.
Ogni piataro dise ben del so pignate.
On lièvore fra du can, on contadin fra du avocati, on malà fra du doturi: chi sta pèzo de luri!
On omo in man del’avocato xe come on sorze in boca al gato.
Par ben lustrare ghe vole ojo de gunbio.
Par San Domin sòmena el contadin.
Par San Gioachin, l’ortolan nel camarin.
Pitosto che soto paron in nave, mèjo paruni de na sèssola.
Pitosto che’l palin, mejo el spazin.
Prima se varda el buso, po’ se fà el caecio.
Quando ch’el xe tajà e inbastìo ogni cuco ghe va drio.
Quando che uno sa fare i capèi el pol farli par qualunque testa.
Se no ghe fusse chi che fà no ghe sarìa chi che magna.
Se no ghe fusse la cola e ‘l stuco el marangon sarìa distruto.
Suòre de stradin e grasso de mussolin guarisse tuti i mali.
Tajo largo, sega streta.
Tanto xe marcante quelo che guadagna che quelo che perde.
Tra arte e busia se vende la marcanzia.
Tuti i mistieri fà le spese.
Vinti munari, vinti sartori e vinti osti fà sessanta ladri.
Numero Proverbi: 67
MORTI: I MORTI E LA MORTE
A chi che ga denaro forte, quando l’è vecio se augura la morte.
Canpane a ore, calcun che more.
Chi che xe destinà par la forca no se nega.
Chi dà via el fato soo prima che’l mora, el merita la morte co la mazola.
Chi no more in cuna ghe ne inpara senpre calcuna.
Chi va pian va lontan, chi va forte va ala morte.
Co poco se vive, co gnente se more.
Co’ i nasse i xe tuti bei, co’ i se marida i xe tuti siuri, co’ i more i xe tuti boni.
Co’ more el vecio la casa se desfa.
Co’ se sta ben se more.
I veci porta la morte davanti e i zòvani de drio.
L’ultimo abito ch’i ne fà l’è senza scarsèle.
L’ultimo che more de fame xe ‘l munaro.
La morte del lovo xe la salute dele piègore.
La morte no ga lunario.
La morte xe senpre pronta, come le tole dei osti.
La tosse xe ‘l tanburo dela morte.
Morire xe l’ultima capèla che se fà.
Morto on papa se ne fà ‘nantro.
Tute le robe storte le fà drite la morte.
Tuti i ossi torna al so logo.
Tuti nasse pianzendo, nissun more ridendo.
Ai Morti e ai Santi i corvi sbandona i monti e i vien a pascolare ai canpi.
Al dì d’i morti la neve xe ale porte.(2/11)
Canpanon a bonora, la xe na trista sagra.
Co’ se xe morti, San Michele pesa le àneme e i preti i candeloti.
El morto in cassa, el vivo se la spassa.
I morti verze i oci ai vivi.
Mèjo piànzarli morti inocenti che vivi delinquenti.
Nadale col mandolato, i Morti co la fava, Pasqua co la fugazza.
Omo vivo pagarà, omo morto ga pagà.
Par i Santi, neve sui canpi; par i Morti, neve sui orti.
Xe mejo ‘ndare in paradiso strazà che al’inferno in abito ricamà.
Numero Proverbi: 33
NOSE: PROVERBI …COME NOSE
A San Roco le nose le va in scroco.(16/8)
A Sant’Ana le nose va in tana.
A Santa Crose, pan e nose.(14/9)
A Santa Madalena la nosa xe piena.(22/7)
De nose on saco, ma no pì de na fémena par casa.
Dopo la crose na pèrtega par le nose.
Nose e done no se sa quale che sia bone.
Nose e pan, magnare da can.
Nose e pan, pasto da vilan.
Pan e nose xe on magnare da spose.
Par San Lorenzo la nosa xe fata.
Quando piove par la Crose, bon el gran, triste le nose.
Se piove ai primi de Majo, nose e fighi fà bon viajo.
Se piove el dì de Santa Crose el fà cascare le nose.
Tèndare le tose e bàtare le nose xe tenpo perso.
Numero Proverbi: 15
OMANI: TUTO SUI OMANI
A l’amo se ciapa el pesse, i òmani a l’intaresse.
Bon naso, fà bel’omo.
Co l’età, l’omo fa panza e la fémena fa stomego.
Co la caveza se liga i cavai, co la parola i òmani.
Co’ nasse na fémena, nasse na serva; co’ nasse on omo, nasse on paron.
Co’l cavéjo tra al bianchin, assa la dona e tiente el vin.
Cusina che fuma, dona cativa e coverta rota manda l’omo in malora de troto.
El naso d’i gati, i zenoci d’i òmani e ‘l culo dele fémene xe senpre fridi.
El pòvaro omo no fa mai ben: se more la vaca ghe vanza el fen, se la vaca scanpa e l fen ghe manca.
El pòvaro omo no l’è da conséjo: el parla ben e no’l xe scoltà, el parla male e ‘l xe picà.
Fumo e dona ciacolona fà scanpare l’omo de casa.
I òmani ala guera e le vache in montagna no se garantisse.
I òmani ga i ani ch’i se sente, le done quei che le mostra.
I siùri more de fame se i poariti no sùa.
L’ocasion fà l’omo ladro.
L’omo da vin no ‘l vale on quatrin.
L’omo el tien su on canton dela casa, la fémena staltri tri.
L’omo fà la dona e la dona fà l’omo.
L’omo maridà porta quatro “p”: pene, pensieri, pentiminti e pecati.
L’omo pì bruto xe quelo che ga le scarsèle roverse.
L’omo propone, Dio dispone.
L’omo: che’l sia san, cristian e che’l sapia guadagnarse el pan.
La bona mojère fà el bon marìo.
La menestra xe la biava de l’omo.
La parola liga l’omo, la corda el musso.
Le montagne sta ferme e i òmani se move.
Mèjo on sorze in boca a on gato che on omo par le man de on avocato.
Mèjo picoli e ben conpìi che grandi e insemenìi.
Né la malatia, né la preson fà deventare l’omo bon.
No ghe xe farina senza sémola, nosèla senza scorza, gran senza paja e omo senza difeti.
Novantanove maridà fà zento bechi.
Ogni galo senza cresta xe on capon, ogni omo senza barba xe on cojon.
Omo de confin, o ladro o assassin.
Omo lodà, o morto o scanpà.
Omo maridà, oselo in gabia.
Omo vivo pagarà, omo morto ga pagà.
On omo in man del’avocato xe come on sorze in boca al gato.
Quando che l’omo xe pien de vin el te parla anca in latin.
Quando che l’omo xe stimà el pole pissare in leto e dire che’l ga suà.
Quando Dio vol castigar un omo el ghe mete in testa de maridarse.
Sa volì conossare na persona, vardè la dona al balo e l’omo al zogo.
Sete òmani no mena drento col caro quanto che na fémena la porta fora co la traversa.
Sola vita de on omo che’l sia on omo ghe xe senpre almanco na ostaria.
Vàrdate da l’omo che porta el recin e dala dona che sa de latin.
Xe pì le done che varda i òmani che le stele che varda la tera.
Numero Proverbi: 45
ORTO: I PROVERBI IN MEZO AL’ORTO
A magnare on spigo de ajo, se spuza come a magnarghene na resta.
A San Simon se cava la rava e ‘l ravanon.(28/10)
Aprile sparesin, Majo saresin.
Chi che ga le zuche no ga i porzei.
Chi magna salata fà la vita beata.
Chi vole on bel ajàro lo pianta de Jenaro.
Co’ riva el trenta de Agosto tute le zuche le va ‘rosto.
Co’ riva le Madone tute le zuche le xe bone.
Da la Befana la rapa xe vana.
De San Luca pianta la rapa e cava la zuca.
Dio te varda dal vermo del fenocio e da chi che ga on solo ocio.
El primo de Aprile, miti le zuche che le vien come on barile.
El simile col simile, ma le verze co l’ojo.
Fin a Nadale magnemo verze e rave.
Ghe xe chi che magna le fave e chi che magna le sgusse.
I fasoi veci nasse in panza.
I fasoi xe la carne di’ poariti.
I mèdeghi e le patate ga i fruti soto tera.
La salata la vole el sale da on sapiente, l’aseo da on avaro, l’ojo da on prodigo, smissià da on mato e magnà da on afamà.
La zeola la xe la rufiana del cuogo.
Le zuche nate fra le do madone le xe le pì bone.
Le zuche vode le sta sora l’aqua.
Le zuche vode vien senpre a gala.
Majo fresco, fava e formento.
No ghe xe erba che varda in su che no gabia la so virtù.
O prima o dopo se fà anca le zuche.
Par l’Anunziata la zuca xe nata.
Quando che la zuca se ingrossa el pecòlo se seca.
Se Majo fà fresco va ben la fava e anca el formento.
Se’l tona el dì de San Duane, le cuche va sbuse e le nosèle vane. (24/6)
Xe mèjo cavarse on ocio che magnare el vermo del fenocio.
Verze e fasòi sbrega i nizòi.
Zuca santa che la canta e baruca che la sia muta.
Zuche e fen int’on mese i vien.
Numero Proverbi: 34
PAN: SE VIVE ANCA DE PAN…
A Santa Crose, pan e nose.(14/9)
Anca i cojuni magna el pan.
Chi che no ga pan ga denti.
Chi no xe bon de rònpare el pan no xe bon de guadagnàrsene.
Col pan se fà balare i can.
Dove che no ghe xe vin da travasare e farina da far pan staghe lontan.
El pan del mona xe el primo magnà.
El pan del poareto xe senpre duro.
El pan in mostra xe l’ultimo vendù.
El vin al saore, el pan al colore.
Faustin, poco pan e tanto vin.
Fin che ghe xe pan in convento, frati no manca.
Formajo, pan bianco e vin puro fà el polso duro.
La piova de San Bernardin la roba pan, ojo e vin.
La speranza xe el pan d’i poariti.
Lìssia e pan: dale done staghe lontan.
Nose e pan, magnare da can.
Nose e pan, pasto da vilan.
Ovo de on’ora, pan de on dì, vin de on ano, dona de quìndese e amigo de trenta.
Pan che canta, vin che salta e formajo che pianza.
Pan e nose xe on magnare da spose.
Pan fin che’l dura, vin a misura.
Pan padovan, vini visentini, tripe trevisane e done veneziane.
Pan, sopressa e conpagnia su ‘nte’l bosco fà alegria.
Pan, vin e zoca, lassa pur che’l fioca.
Soto la neve, pan; soto l’aqua, paltan.
Numero Proverbi: 26
PERLE: PERLE…
A caminare a stravento se fa senpre fadiga.
A chi carne de testa e a chi de colo.
A chi nasse scarognà ghe piove sol culo stando sentà.
A comiziare i lavori de vènare la roba va in zénare.
A dire busie ghe vole bona memoria.
A dire la verità ghe vole on cojon, a dire busie ghe vole on bricon.
A far credenza se perde l’aventore.
A far la carità no se va in miseria.
A l’astuzia del munaro no gh’è mai nissun riparo.
A l’osèlo ingordo ghe crepa el gosso.
A lavarghe la testa al molton, se consuma l’aqua e anca el saon.
A on belo senpre ghe manca, a on bruto senpre ghe vanza.
A pensar mal se fa pecà, ma se indovina senpre.
A parlare se fa presto: pì difìzile xe el resto.
A quatro a quatro se inpinisse el saco.
A quel che vien da sóra no ghe xe riparo.
A robare poco se va in galera, a robare tanto se fa cariera.
A sentarse so do careghe el culo se sbrega.
A vìvare co la testa sol saco xe bon ogni macaco.
Al cao de là fa la pitona.
Al ciaro de luse ogni stronzo traluse.
Amore fa amore, cativeria fa cativeria
Anca i cojuni magna el pan.
Anca la cossienza fa el calo.
Anca na bruta sìmia pole fare on bel salto.
Aqua passà no masena pì.
Aqua turbia no fa specio.
Arte toa, nemigo too.
Articolo quinto: chi che ga schei ga senpre vinto.
A viajare se se descanta, ma chi che parte mona torna indrio mona.
Barca fondà no ga bisogno de benedission.
Baso devoto no vole èssare visto.
Baso par forza no vale na scorza.
Beati i ultimi se i primi ga creanza.
Ben, bon e magari i jera tri che fabricava lunari.
Bisogna che ghe sia chi che fà parché ghe sia chi che magna.
Bisogna tacare el musso dove che vole el paron.
Boca onta no la pole dire de no.
Boca sarà no ciapa moschini.
Bondanza e roganza xe tuta na piatanza.
Bone parole e cativi fati ingana savi e mati.
Bota che canta la xe voda.
Bronza cuerta brusa la traversa.
Can che baja no mòrsega.
Canpo pestà no produse erba.
Carità par forza, fiore che spuza.
Carne che cresse no sta mai ferma.
Carta canta, vilan dorme.
Chi arte no sà, botega sara.
Chi che dal loto speta socorso, mostra le bale come l’orso.
Chia canta a tola o in leto l’è on mato perfeto.
Chi che ga da vere ga da dare.
Chi che ga la rogna se la grata.
Chi che ga le zuche no ga i porzei.
Chi che ga santoli ga buzolà.
Chi che ga schei ga senpre rason.
Chi che grata la rogna ai altri rinfresca la soa.
Chi che massa se inchina mostra el culo.
Chi che nasse tacà a on fosso spuza senpre da freschin.
Chi che no ga pan ga denti.
Chi che ronpe de vecio paga de novo.
Chi che siòla ga pensieri.
Chi che va par i spini i xe quili descalzi.
Chi che varda i fati di’ altri i sui ghe va da malo.
Chi che varda in suso se inbalza.
Chi che xe vizin ala cusina magna minestra calda.
Chi cominzia ben el primo de l’ano sta ben tuto l’ano.
Chi da galina nasse, da galina ruspa.
Chi dòpara loame no ga mai fame.
Chi fa la pignata sa fare anca el manego.
Chi ga fato le pignate pol anca rònparle.
Chi ga la caza in man minestra a so modo.
Chi ladra, Dio ghe dona; chi no ladra, pioci e rogna.
Chi more el mondo assa, chi vive se la spassa.
Chi no ga testa ga ganbe.
Chi no laora no magna.
Chi no magna ga magnà.
Chi no sa rìdare no sa vìvare.
Chi no se inzegna fa la tegna.
Chi òrdena paga.
Chi pì capisse pì patisse.
Chi pì xe, manco se vanta.
Chi sbaglia de testa paga de scarsela.
Chi somena spini no vaga descalzo.
Chi sparagna el gato magna.
Chi va a l’osto perde el posto.
Chi va pian va lontan, chi va forte va ala morte.
Chi va sa calcossa, chi manda speta risposta.
Chi va via perde la partia.
Chi vole ‘ndare massa in suso, casca par tera e se ronpe el muso.
Co la caveza se liga i cavai, co la parola i òmani.
Co la panza piena se rajona mèjo.
Co’ capita on bon bocon, mona chi che no ghe ne aprofita.
Co’ ghe n’è massa le cioche se beca.
Co’ i ladri se fa la guera, segno ch’i xe d’acordo.
Co’ i picoli parla i grandi ga parlà.
Co’ la carne xe frusta l’ànema deventa justa.
Co’ la oja la xe pronta le ganbe se fà liziere.
Co’ manca el méjo i osei se beca.
Co’ na man se da e co’ staltra se riceve.
Co’ no ghe xe pì gànbari, xe bone anca le zate.
Co’ parla na bela dona la ga senpre rason.
Co’ se ciapa on vizio se stenta a pèrdarlo.
Co’ se ga scumizià no ghe xe pì retegno.
Co’ te vidi par strada on bòzolo, no starte fermare: o pesi da portare o bote da ciapare.
Coi birbi el galantomo fà senpre la figura del cojon.
Col minestro che se minestra se vien minestrà.
Dai cupi in su nissun sa gnente.
Dele volte na busia salva la verità.
Dove che ghe vole fati, no basta le parole.
Dove che manca i cavai anca i mussi trota.
Dove che passa la barca pol passare anca el batelo.
Dove no ghe xe ocio no ghe xe làgreme.
Drio ai ani ghe va el judizio.
Dura depì na pignata rota che una sana.
El baston xe on cativo maestro.
El bisogno insegna a far de tuto.
El butare via xe parente del piànzare.
El carbon l’inzende o l’intenze.
El desperà xe senpre castrà.
El fruto no’l casca mai lontan da l’àlbaro.
El judizio salva l’osso del colo.
El lume xe na meza conpagnia.
El mondo xe grande: basta voler caminare.
El mondo, mezo el xe vendù e mezo el xe da vèndare.
El nome di’ zucuni xe scrito sui cantuni.
El pan del paron el ga tre croste.
El poco basta, el massa guasta.
El rùzene magna el fero.
El sapiente sa poco, l’ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto.
El tènaro ronpe el duro.
El tenpo no ghe fà torto a nissuni.
El tenpo e la rason xe senpre del paron.
Facile xe piantare ciodi, ma dificile xe s-ciodarli.
Fin che dura i bezi, amighi no manca.
Fin che dura la menada dura la polenta.
Fin che dura sto regno, scarpe de legno.
Fin che l’invidioso se rode, l’invidia se gode.
Fogo de paja e troto de vecia dura poco.
Fra’ Modesto no’l xe mai deventà priore.
Frua la bareta chi se la cava a tuti.
Ghe xe pì dì che luganega.
Ghe xe pì tenpo che vita.
Gnente, xe bon pa’i oci.
I “se” e i “ma” se du ebeti da Adamo in qua.
I bauchi casca senpre par tera.
I curiusi se paga al sabo.
I fasoi veci nasse in panza.
I muri veci fà panza.
I oci del spazacamin xe senpre bianchi.
I ovi xe boni anca dopo Pasqua.
I parenti xe come le scarpe: pì striti i xe, pì male i fà.
I schei no i ga ganbe ma i core.
I siùri more de fame se i poariti no sua.
In tenpo de peste pì baje che feste.
L’omo da vin no ‘l vale on quatrin.
L’onore xe come el vento: el va fora da tuti i busi.
L’union dela fameja sta int’el casson dela farina.
La boca la se liga solo ai sachi.
La bona maniera la piase a tuti.
La burla no la xe bela se no la xe fata a tenpo.
La coa massa longa xe quela che copa la volpe.
La coéga cola sol lardo.
La fadiga fa catare l’inzegno.
La fortuna la va drio ai orbi.
La frégola la vien dal toco.
La joza scava la piera.
La justizia xe fata a maja.
La léngoa no ga osso, ma la pole rónpare i ossi.
La pezo roa del caro xe quela che ruza.
La pigrizia la va tanto pian che la miseria la ciapa.
La ràza no va su par el talpon.
La roba che se buta via coi piè, vien dì che la se rancura co le man.
La roba donà fà male ala panza.
La roba no xe de chi che la fà, ma de chi che la gode.
Le bone azion xe come le vivande, che no le vale gnente co’ le spuza da fumo.
Le bone parole onze, le cative ponze.
Le ciàcole no inpasta fritole.
Le maravéje dura tri dì.
Le montagne sta ferme e i òmani se move.
Le novità le piase a chi che no ga gnente da pèrdare.
Le parole no inpinisse la panza.
Le zuche vode le sta sora l’aqua.
Le zuche vode vien senpre a gala.
Laòro tacà finìo par metà.
Mai assàre la strada vecia par quela nuova.
Mèjo ‘vere du schei de mona che passare par massa svejo.
Mèjo el tacon del sbrego.
Mèjo le braghe sbuse sol culo che el culo sbuso so le braghe.
Mèjo na torta in du che na merda da ti solo.
Mèjo on ovo oncuò che na galina doman.
Méjo on piato de bela ziera che zento pastizi.
Misura el ciodo prima de piantarlo.
Na joza de miele conza on mare de fiele.
Na man lava l’altra e tute do lava el muso.
Na mota e na busa fà on gualivo.
Na pena ala volta se pela l’oca.
Na serenada de note dura fin che on can fà le balote.
Né na parola dita, né on naso tirà no torna indrio.
Né panza, né rogna, né tosse se sconde.
No bisogna magnare i ovi prima de verghe cavà la sgussa.
No fare el passo pì longo del ganba.
No ghe xe avere che conta depì del savere.
No ghe xe carne in becaria che presto o tardi no la vaga via.
No ghe n’è mai a bastanza se no ghe ne vanza.
No ghe xe mai ben che no gabia el so male.
No ghe xe nessun ladron che no gabia la so devozion.
No ghe xe pignata che covercio no la cata.
No ghe xe rizeta par la paura.
No ghe xe sordo pì grande de quelo che no vole scoltare.
No ghe xe straza che no la vegna bona.
No pole èssare jutà chi che no vole èssare consilià.
No se fà on capelo par na sola piova.
No se ga se no quel che se gode.
No se pole avere la bota piena e la mojère inbriaga.
No se pole caminare sola neve senza assare peche.
No se pole cantare e portare la crose.
No se pole far cagare i mussi par forza.
O basa sto cristo o salta sto fosso.
O magna sta minestra o salta sta finestra.
O prima o dopo se fà anca le zuche.
Ogni bela scarpa deventa na bruta zavata.
Ogni dì nasse on cuco.
Ogni mosca la fa la so onbra.
Ogni paese ga le so usanze, ogni porta ga el so batocio.
Omo lodà, o morto o scanpà.
On alto e on basso fà on gualivo.
On bel védare fà on bel crédare.
Onore de boca poco vale e manco costa.
Par gnente l’orbo no canta.
Par savere la verità bisogna sentire du busiari.
Parere e no èssare xe come filare e no tèssare.
Pesse grosso magna pesse picolo.
Prima de parlare, tasi.
Quando che l’aqua toca el culo tuti inpara a noare.
Quando che la barca va ogni cojon la para.
Quando che la merda monta in scagno, o che la spuza o che la fà dano.
Quando che no se pole ciapare el pesse se ciapa le rane.
Quando che uno sà fare i capèi el pol farli par qualunque testa.
Quel che se vede no xe de fede.
Quelo che no sòfega ingrassa.
Quelo che no strangola ingrassa e quelo che no ingrassa passa.
Reve e guseleta* mantien la poareta.
Roba fruà no tien ponto.
Roba robà no fà conpanàdego.
Roba robà, come la vien la va.
S’ciopo vodo fà paura a du.
Sa fusse, sa ghesse e magari i jeri tri sumàri.
Sa volì ca ve lo diga ve lo digo: chi che casca in povertà perde l’amigo.
Saco roto no tien méjo.
Saco vodo no sta in piè.
Scarpa larga e goto pien, ciapa le robe come le vien.
Scarpe vecie sparagna le nove.
Se l’invidia fusse freve tuto el mondo scotaria.
Se le parole paghesse dazio, sarìa on afar serio.
Se no ghe fusse chi che fà no ghe sarìa chi che magna.
Senpre stenta chi no se contenta.
Senza ojo el lume se stua.
Senza spie no ce ciapa ladri.
Svodà la scudela, tuti ghe spua dentro.
Tacà a on ciodo, ma vivo.
Tanti paìsi e tante usanze, tante teste e tante panze.
Tanto toca a chi roba come a chi che tien el saco.
Testa de musso no se pela mai.
Togno fà la roba, el sior Toni la gode, el conte Antonio la magna.
Tre cosse ghe vol par farse siori: o robar, o trovar, o ereditar.
Tre volte bon fà mona.
Trista chela bestia che no para via le mosche co’ la so coa.
Troti de musso e salti de vecio dura poco.
Tute le robe storte le fà drite la morte.
Tute le scarpe no va ben ‘ntel stesso piè.
Tuti ga el so toco de invidia.
Tuti ga la so ora de mona.
Tuti gode a védare i mati in piazza, pur che no i sia dela so razza.
Tuti i mistieri fà le spese.
Tuti nasse pianzendo, nissun more ridendo.
Tuti semo fioi de Adamo.
Tuti va al molin col so saco.
Tuto finisse, via che l’invidia.
Tuto ga fine.
Tuto se justa, fora che l’osso del colo.
Tuto va e vien e gnente se mantien.
Uno no fà canpion.
Uno roba la polpa e ‘staltro ciapa la colpa.
Vale depì na candela davanti che on candeloto de drio.
Vale depì on no co creanza che on sì vilan.
Vedendo uno te lo conossi mezo, co’ ‘l parla te lo conossi tuto.
Xe mèjo on “to” che zento “te darò”.
Xe on bravo can el can che furfa par elo.
Numero Proverbi: 289
PESCE: EL PESSE IN MEZO AI PROVERBI
A l’amo se ciapa el pesse, i òmani a l’intaresse.
A magnare el zervelo del pesse se deventa intelijente.
Bacalà a ‘la visentina, bon de sera e de matina.
Barbi e rane mai de Majo, parché i fa tristo passajo.
Carne zòvane e pesse vecio.
Chi magna carpion no xe on babion.
Co’ no ghe xe pì gànbari, xe bone anca le zate.
De la Sensa le granseole fà partensa.
De Marzo no bisognarìa che pissesse gnanca na rana.
De pesse scanpà no se ne ga mai magnà.
Done, cani e bacalà no i xe boni se no i xe pestà.
El lusso magna la tenca.
El pesse ga da noare tre volte: prima ‘ntel’aqua, dopo ‘ntel’ojo e la terza ‘ntel vin.
El pesse guasta l’aqua, la carne la conza.
El pesse spuza dala testa.
L’ospite xe come el pesse: dopo tri dì el taca a spuzare.
La testa del barbon xe el mejo bocon.
Magari polenta e pessin, ma na bela testa sol cussin.
Magnà i gànbari se ciucia anca le zate.
Magna renghe e sardeloni: te conservarè i polmoni.
Marsoni friti e polentina, on fià de vézena e vin de spina.
Nela luna setenbrina la sardela se rafina.
Pesse grosso magna pesse picolo.
Quando che la spiga ponze, la sardela onze.
Quando che no se pole ciapare el pesse se ciapa le rane.
Quando la rosa buta el spin, magna gò e passarin.
Quando se vede la raìna se no piove oncuò piove domatina.
Tenca de Majo e luzo de Setenbre.
Tien on ocio al pesse e ‘nantro al gato.
Tra i pessi on bel ronbeto, tra i quadrupedi el porcheto.
Numero Proverbi: 30
PORCARIE: NO XE TUTO ORO QUELO CHE SLUSE ….MA ANCA QUELO CHE NO SLUSE POLE VALERE ORO!
A chi nasse scarognà ghe piove sol culo stando sentà.
A dire la verità ghe vole on cojon, a dire busie ghe vole on bricon.
A ogni culo el so cagare.
A ogni uno ghe piase la so spuzeta.
A sentarse so do careghe el culo se sbrega.
A tirarse massa indrio se finisse col culo in rio.
Al ciaro de luse ogni stronzo traluse.
Al son de la canpana (schei) ogni dona se fa putana.
Ala de capon, culo de castron e tete de massara xe na roba rara.
Amare e no éssare amà, xe come forbirse el culo senza vere cagà.
Amore, merda e zéndare le xe tre robe tèndare.
Anca i cojuni magna el pan.
Ano piovoso, ano de merda.
A viajare se se descanta, ma chi che parte mona torna indrio mona.
Bisogna avere oci anca sol culo.
Botega de canton fà schei ogni cojon.
Bruta de muso, larga de buso.
Buta via la roba tri dì dopo che la spuza.
Cafè de colo, ciocolata de culo.
Cava erba e miti merda.
Caval, putana e persegar trent’ani no i pol durar.
Cavalo vecio e servo cojon no inbroja el paron.
Chi che dal loto speta socorso, mostra le bale come l’orso.
Chi che massa se inchina mostra el culo.
Chi che nasse tacà a on fosso spuza senpre da freschin.
Chi che pissa contro vento se bagna la camisa.
Chi che se marida de carnevale slonga le ganbe e scurza le bale.
Chi che se marida e no sa l’uso, fa le ganbe fiape e longo ‘l muso.
Chi dise “ma” in culo lo ga.
Chi dòpara loame no ga mai fame.
Chi ga el cao dala soa ga in culo i sbiri.
Chi vol fare el stronzo massa grosso ghe vien le làgreme ai oci.
Chi vol stare san pissa spesso come on can.
Co le done e co le merde se barufa e po’ se perde.
Co’ capita on bon bocon, mona chi che no ghe ne aprofita.
Co’ i xe pì i passi che i boconi l’è on andare da cojoni.
Co’l lovo* deventa vecio i can ghe pissa incoste.
Coi birbi el galantomo fà senpre la figura del cojon.
Culo che caga no ghe xe oro che lo paga.
De Marzo no bisognarìa che pissesse gnanca na rana.
De siuri ghe n’è de tre sorte: siorsì, siorno’ e sior mona.
Daghe da magnare a on vilan che dopo el te caga in man.
Debito sputanà, debito pagà.
Dona nana, tuta tana.
Dopo i ..anta ganbe che trèmola, tete che scanpa.
Dove che ghe xe canpagne ghe xe putane.
Dura depì i loamari che i pajari.
El bon figo ga da vere camisa da pitoco, colo da picà e culo da pescadore.
El diavolo va a cagare senpre sol monte pì grande.
El laòro dela sega el slonga i brazi e ‘l scurza la tega.
El loame de cavalo el fruta on ano e no sò qualo.
El musso, co’l ga magnà el volta el culo ala grupia.
El naso d’i gati, i zenoci d’i òmani e ‘l culo dele fémene xe senpre fridi.
El pan del mona xe el primo magnà.
El pesse spuza dala testa.
El sapiente sa poco, l’ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto.
El tenpo, el culo e i siuri i fà quelo ch’i vole luri.
Fighi e ùa, el culo se frùa.
I cojuni del can e i schei del vilan i xe i primi mostrà.
I mona se conosse da do robe: dal parlare, quando ch’i dovaria tasére e dal tesére quando ch’i dovaria parlare.
I nostri veci stava zento ani col culo ala piova prima de fare on proverbio.
In istà la vache va in montagna a fare le siore, e le siore va in montagna a fare le vache.
L’aqua morta fà spuza.
L’aria de Febraro xe come on loamaro.
L’avaro farìa de manco de cagare par no butare via gnanca quela.
L’ospite xe come el pesse: dopo tri dì el taca a spuzare.
La boca e el culo xe fradei.
La fémena xe come on falzin: batarla ogni tanto, guzarla senpre.
La merda fà schei.
La passienza xe la minestra dei bechi e la speranza xe l’altare dei cojoni.
La piègora xe benedeta dal culo e maledeta dala boca.
La rason del poareto no la vale on peto.
La vita xe come na scala par le galine: curta e piena de merde.
Le fémene no sa de èssare sentà dessora ala so fortuna.
Le maledission le salta de qua e de là e le finisse sol culo de chi che le ga dà.
La mojere xe come na scoreza: o ti ‘a moli o ti ‘a sòfeghi.
Le tose lo desidera, le maridà lo prova, le vedove lo ricorda.
Le vache pissa, i manzi sbrissa e i bo’ veci xe quei che tira.
Loame, rivai e cavedagne, benedission dele canpagne.
Mal de testa vole magnare, mal de panza vole cagare.
Maroni e vin novo, culo mio te provo.
Maroni e vin novo, scoreze de fogo.
Mèjo ‘vere du schei de mona che passare par massa svejo.
Mèjo le braghe sbuse sol culo che el culo sbuso so le braghe.
Mèjo na torta in du che na merda da ti solo.
Mèjo on tacon che mostrare el culo.
Merda e aqua santa fà la racolta tanta.
Na bona aqua de Febraro vale pì de on loamaro.
No revoltare la merda, parché la spuza.
No se pole far cagare i mussi par forza.
Novantanove maridà fà zento bechi.
Oci mori, rubacuori; oci bisi, paradisi; oci celeste fà inamorare; oci bianchi fà cagare.; ocio moro, ocio da putana.
Ogni can mena la coa, ogni mona vol dire la soa.
Ogni fémena xe casta se no la ga chi la cazza.
On galo senza cresta xe on capon, on omo senza barba xe on cojon.
On palo in piè, na stropa domà e na fémena colgà i porta quanto peso che te voi.
On pomo de matina te cava el cataro e te fa pissare ciaro.
Par scòndare i difeti basta frequentare conpagnie dela stessa cagà.
Par volere savere de tuto se sa anca de mona.
Pì in alto se va e pì se mostra el culo.
Picola al balo, grande a cavalo.
Pitosto che le tarme la magna, xe mejo che i osei la bècola.
Polenta e late ingrossa le culate.
Putei e colunbi insmerda la casa.
Quando che l’aqua toca el culo tuti inpara a noare.
Quando che l’omo xe stimà el pole pissare in leto e dire che’l ga suà.
Quando che la barca va ogni cojon la para.
Quando che la merda monta in scagno, o che la spuza o che la fà dano.
Quando che la zuca se ingrossa el pecòlo se seca.
Quando la dona trà l’anca, o no la xe vaca o poco ghe manca.
Quando la merda varà calcossa, i poariti nassarà senza buso del culo.
Rìdare e vardare xe parente del cojonare.
Risi bianchi, magnare da béchi.
Rossa de pelo, mata par l’oselo.
Santi che pissa in tera no ghe n’è.
Schei, poderi e canpi e na bela coa davanti.
Se Marzo buta erba Aprile buta merda.
Se no te caghi te cagarè, se no te pissi te creparè.
Se tuti i bechi portasse on lanpion, che gran iluminazion.
Se varda on sbaro de erba: se pol vardare anca na persona piena de merda.
Sfogo de pele, salute de buele.
Sia da cavalo che da mulo sta tri passi lontan dal culo.
Signore, fà ca no sia beco; se ghe so’, fà ca no lo sapia; se lo sò, fà ca no ghe bada.
Stajon de erba, stajon de merda.
Stimar la roba in erba l’è on stimar de merda.
Tira depì on pelo de mona che on paro de buò.
Tre volte bon fà mona.
Tri calighi fà na piova, tre piove na brentana e tri festini na putana.
Tripe de merda parché l’osto no ghe perda.
Tronba de culo, sanità de corpo.
Tuti ga la so ora de mona.
Tuti i stronzi fuma.
Tuti quanti semo mati par chel buso ca semo nati.
Vale depì on gran de pévaro che on stronzo de musso.
Vàrdate dal culo del mulo, dal dente del can e da chi che tien la corona in man.
Verze e fasòi sbrega i nizòi.
Viajare descanta, ma chi che parte mona torna indrio mona.
Vin novo, braghe leste.
Xe inutile fermare el treno col culo.
Xe mèjo èssare bechi e ver da becare che no èssare bechi e no ver da magnare.
Numero Proverbi: 140
PRETI….SUI PRETI
A Messa, tuti no pole stare tacà al prete.
Chi va a Roma e porta on borsoto, deventa abate o vescovo de boto.
Co’ se xe morti, San Michele pesa le àneme e i preti i candeloti.
Come che xe grossa la candela, i preti alza la ose.
Confessori e bròcoli i xe boni fin a Pasqua.
Davanti al prete, al dotore e a on capitelo càvate senpre el capelo.
Dotori e preti no dà mai gnente a nissun.
El bon vin se trova dal paroco.
Fin che ghe xe pan in convento, frati no manca.
I preti fà bòjare la pignata co le fiame del purgatorio.
I siuri more de fame, i poariti de indigestion, i frati de caldo e i preti de fredo.
L’amigo del prete perde la relijon, l’amigo del dotore perde la salute, l’amigo del’avocato perde la causa.
La panza d’i preti xe el zimitero d’i capuni.
Morto on papa se ne fà ‘nantro.
Odio de preti, vendeta de frati e rogna de ebrei, miserere mei.
Par on frate scontento no se sara el convento.
Predica curta, sopressa longa.
Prete in capela, novità bela.
Prete, dotore e comare, no te ne ingatejare.
Quando canbia on prete, tra fare e desfare l’è tuto on laorare.
Sa pì el papa e on contadin che el papa da elo solo.
Sa volì védare el diluvio universale, metì dodese preti a tola a magnare.
Sbaglia anca el prete a dir messa.
Senza stola no se confessa, senza schei no se canta messa.
Vàrdate da prete, contadin, da comare, vizin e da aqua par confin.
Numero Proverbi: 25
SANTI: QUA SE PARLA DE SANTI … QUASI TUTI IN CANPAGNA
A ‘la Madona del Rosario el pitaro* de passajo.(6/10)
A ‘la Madona i pitari ne sbandona.
A ‘la Madona le quaie ne sbandona.
A ‘la prima Madona le se smorza, a ‘la seconda le se inpiza. (15/8 – 8/9)
A ‘la Salute se veste le bele pute.(21/11)
A chi che no ghe piase el vin , che Dio ghe toga anca l’aqua.
A l’Ave Maria ogni òpara xe conpia.
A l’Imacolata se scumizia l’invernata.
A la vizilia de San Joani piove tuti i ani.(24/6)
A San Baldoin se fa el vin.
A San Bassan on fredo da can.(19/1)
A San Belin el jazo sol caìn.(12/10)
A San Benedeto la vegna su par el paleto.
A San Benedìo le ròndene torna indrio.(21/3)
A San Bernardin fiorisse el lin. (20/5)
A San Bonaventura el medare* l’è finio in pianura. (15/7)
A San Bovo se ronpe el primo ovo. (2/1)
A San Clemente l’inverno mete el dente.(23/11)
A San Crispin se pesta el vin.(25/10)
A San Donato el fredo l’è fato. (7/8)
A San Firmin, sòmena el contadin. (11/10)
A San Francesco i tordi i va de furia.(4/10)
A San Gioachin el primo freschin. (20/8)
A San Gorgon passa la lòdola e ‘l lodolon.(9/9)
A San Gorgon xe finio el tenpo bon.
A San Luca el ton el va in zuca.(18/10)
A San Luca le lòdole se speluca.(18/10)
A San Martin casca le foje e se beve el bon vin.
A San Martin el mosto deventa vin.
A San Martin se calza el grande e anca el picenin.(11/11)
A San Martin se spina el bon vin.
A San Martin, castagne e vin.
A San Matìo el bel tenpo xe finio. (21/9)
A San Matìo el primo tordo xe mio.
A San Modesto el fredo vien col zesto. (12/1)
A San Nicòlo tira la neve sol colo.(6/12)
A San Pelegrin, poca paja e poco vin. (5/5)
A San Roco le nose le va in scroco.(16/8)
A San Roco le quaie le va de troto.
A San Roco le ròndene fà fagoto.
A San Saturnin la neve sol camin.(28/11)
A San Simon le lòdole a valon.(28/10)
A San Simon se cava la rava e ‘l ravanon.(28/10)
A San Tizian on fredo can. (16/1)
A San Valentin el giazo no tien gnanca pì on gardelin.(14/2)
A San Vio le zarese le ga el marìo.
A San Zen, somenza in sen.(12/4)
A Sant’Agnese el fredo passa le sfese. (21/1)
A Sant’Ana el rondon se slontana.(26/7)
A Sant’Ana le nose va in tana.
A Sant’Andrea el fredo el monta in carega.(30/11)
A Sant’Andrea se veste tuta la fameja.
A Sant’Antonio (Abate) on passo* de demonio.(17/1).
A Sant’Antonio dala barba bianca o piova o neve no la manca.
A Sant’Erman le arte* in man. (8/2)
A Sant’Isaco, el formento fora dal saco.(19/10)
A Sant’Ubaldo se fa vanti el caldo.(16/5)
A Sant’Urban el formento el fa el gran.
A Santa ‘Fema, se scumizia la vendema.(s. Eufemia, 16/9)
A Santa Catarina el fredo se rafina. /25/11)
A Santa Catarina el jazo so la pissina.
A Santa Catarina la neve se inchina.
A Santa Caterina se tira zo la scaldina.(25(11)
A Santa Crose, pan e nose.(14/9)
A Santa Fiorenza xe oncora bona la somenza. (27/10)
A Santa Liberata freda l’invernata.(18/1)
A Santa Lucia la note pì longa che ghe sia.(13/12).
A Santa Madalena la nosa xe piena.(22/7)
A Santa Madalena piove apena.
A Santa Madalena se taja l’avena.
A Santa Pologna la tera perde la rogna. (9/2)
A Santa Toscana el riso el va in cana. (14/7)
A Santa Toscana i rondoni se slontana.(14/7)
Ai du passa la nuvola del Perdon. (2/8)
Ai Morti e ai Santi i corvi sbandona i monti e i vien a pascolare ai canpi.
Ai santi veci no se ghe inpiza candele.
Al dì d’i morti la neve xe ale porte.(2/11)
Ala Madona de Agosto rinfresca el bosco.(15/8).
Ala vizilia de San Piero vien fora so mare.(29/6)
Bisogna inpizare na candela al demonio e una a Sant’Antonio.
Candelora, de l’inverno semo fora.
Carnevale e Quarésema, par el pitoco xe la medesema.
Che Dio el ne varda dal seco tra le do Madone.
Chi ciama Dio no xe contento, chi ciama el diavolo xe disperà, chi dise ahimè xe inamorà.
Chi dà ai pòvari inpresta a Dio.
Chi ladra, Dio ghe dona; chi no ladra, pioci e rogna.
Chi sparte e no se ne tien, el Signore no ghe vole gnanca ben.
Co l’Adolorata se va verso l’invernata.
Co’ i ga voltà el messale la messa pì no vale.
Co’ riva le Madone tute le zuche le xe bone.
Co’ se xe morti, San Michele pesa le àneme e i preti i candeloti.
Confessori e bròcoli i xe boni fin a Pasqua.
Da la Befana la rapa xe vana.
Da San Giorgio se sòmena l’orzo. (23/4)
Da San Marco la vigna buta l’arco.(25/4)
Da San Martin a Nadale ogni poareto sta male.
Da San Matia oncora neve par la via.
Da San Matio ogni fruto xe bonio.
Da San Valentin guerna l’ortesin. (14/2)
Dai Santi tote sierpa e guanti.
Davanti al prete, al dotore e a on capitelo càvate senpre el capelo.
De la Candelora el dì cresse oncora.
De la Salute meti le maneze ale pute.
De la Sensa le granseole fà partensa.
De Pasqua no ghe xe galina che no faza.
De San Luca pianta la rapa e cava la zuca.
De San Martin se sposa la fiola del contadin.
De San Martin se veste el grande e anca el picenin.
De San Michele la piova la bagna la pele.
De San Michele se calza le brute e anca le bele. (29/9)
De San Piero el formento e anca el pero.
De San Tomìo le zornade torna indrio.
De San Valentin fiorisse el spin.
De Sant’Antonio el formento indora. (13/6)
De Sant’Urban la segala conpisse el gran.
De Santa Giustina tuta la ua xe marzemina.
Del Pardon (d’Assisi) se trà la zapa in t’on canton.
Dele volte el Santo xe grande, ma el miracolo xe picolo.
Dio li fà e po’ li conpagna.
Dio manda el fredo secondo i pani.
Dio me varda dala rabia dei boni.
Dio te varda da on magnadore che no beve.
Dio te varda dal vermo del fenocio e da chi che ga on solo ocio.
Dio vede e Dio provede.
Dopo i Santi, fora el tabaro e anca i guanti.
Dopo la crose na pèrtega par le nose.
El miracolo no fà el Santo.
Falo de mèdego, volontà de Dio.
Faustin, poco pan e tanto vin.
Fin a Nadale magnemo verze e rave.
Fin dai Santi sòmena i canpi.
I du Santi del giazo: San Luigino e San Paolino i porta l’Inverno de Giugno.
I ovi xe boni anca dopo Pasqua.
I Santi novi scalza i veci.
Incalmà in onore de San Francesco, se no’l taca de verde el taca de seco.
I Santi de casa no fà miracoli.
L’altissimo de sora ne manda la tenpesta, l’altissimo de soto ne magna quel che resta, e in mezo a sti du altissimi, restemo povarissimi.
L’aqua de San Gaetano la tole l’afano.(7/8)
L’aqua de San Giacomo la fà miracoli.
L’aqua de San Gregorio fà ranpegare la végna.
L’aqua de San Joani guarisse tuti i malani.
L’aria de San Matìa (24/2) dura fin a San Giorgio, e l’aria de San Giorgio dura fin a S.Urban.
L’istà de San Martin dura tri dì e on pochetin.
L’omo propone, Dio dispone.
La piova de San Bernardin la roba pan, ojo e vin.
La piova del’Assension fà bela la stajon.
La strigheta mete le feste in sacheta.
La vigilia de San Joani piove tuti i ani.
Le canpane de San Martin vèrze le porte al vin.
Le zuche nate fra le do madone le xe le pì bone.
Nadale col mandolato, i Morti co la fava, Pasqua co la fugazza.
No ghe xe on sabo santo al mondo che la luna no gabia fato el tondo.
No ghe xe polastrina che par le feste de Pasqua no sia galina.
No se pole ‘ndare in paradiso a dispeto di’ Santi.
Novenbre, co San Martin ano novo par el contadin.
Ogni Santo juta.
Ogni Santo vole la so candela.
Par i Santi, neve sui canpi; par i Morti, neve sui orti.
Par l’Anunziata el rossignolo so la saca.
Par l’Anunziata la zuca xe nata.
Par San Barnabà el dì pì longo de l’Istà.
Par San Corado vèrzi la porta al caldo.
Par San Damàso el fredo al toca el naso.
Par San Domin sòmena el contadin.
Par San Fredian la neve la va al monte e al pian.
Par San Gioachin, l’ortolan nel camarin.
Par San Lorenzo la nosa xe fata.
Par San Matio le jornade torna indrio.
Par San Paolo el jazo va al diavolo.
Par Sant’Antonin, poca paja e poco vin.
Par Santa Cristina se sòmena la sajina.
Par Santa Fiorenza xe oncora bona la somenza.
Par Santa Pologna la tera la perde la rogna.
Par Santa Taresa prepara la tesa.
Par tuti i Santi, manegoti e guanti.
Pasqua vegna quando se voia, la vien co la frasca e co la foia.
Pifania, el pì gran fredo che ghe sia.
Piova de San Piero, piova col caldiero.
Piova de San Roco la dura poco.
Quando che l’Anzolo Michele se bagna le ale piove fin a Nadale.
Quando che piove el dì de San Gorgon, piove par na stajon. (9/9)
Quando piove par la Crose, bon el gran, triste le nose.
Quando semo a San Simon, ogni straza la vien bon.
San Bastian ga la viola in man.
San Benedeto ghe ne porta on sacheto*. (21/3)
San Biasio, el fredo va adasio.
San Biasio, ultimo barbon marcante de neve.(3/2)
San Bogo, la torta al fogo.
San Colonban el riva co la neve in man. (21/11)
San Gregorion el pole portare on robalton. (3/9)
San Mauro fà i ponti, Sant’Antonio li ronpe, San Paolo li fonda.
San Paolo ciaro inpinisse el granaro. (25/1)
San Paolo San Paolon, tote su la scala e va a bruscare el vegnon.
San Piero benedisse la tenpesta.
San Prodocimo e San Daniele marcanti de neve. (7/11)
San Valentin dal fredo fin, l’erba la mete el dentin.(14/2)
San Valentin, el jazzo no’l tien pì gnanca on gardelin.
San Vidale, marcante de piova. (28/4)
San Vincenzo, gran fredura; San Lorenzo, gran calura: l’uno e l’altro poco i dura.
Sant’Agostin, daghe el primo pontin. (28/8)
Sant’Agostin, taca le màneghe al bustin.
Sant’Antonin el vien lezièro: ormai semo ale asse sia in stala che in granaro. (10/5)
Sant’Antonio Abate se no ghe xe el jazzo el lo fà, se’l ghe xe el lo desfa.
Sant’Antonio Barbon (Abate) marcante de neve.
Sant’Antonio del paneto el vien col segheto. (13/6)
Sant’Antonio se ga inamorà de on porzeleto.
Sant’Omobon, neve o tenpo bon. (13/11)
Sant’Urban pastore de nuvole.
Santa Barbara benedeta, tien distante el fulmine e la saeta. (4/12)
Santa Eulalìa el fredo la porta via. (12/2)
Santa Fosca, se giazo la trova col fuso la scoa; se giazo no la ghe n’à catà, giazo la fà. (13/2)
Santa Giuliana el fredo se rufiana. (16/2)
Santa Giustina dela sgussetina. (7/10/)
Santa Luzzia el fredo cruzzia.(13/12)
Santa Madaléna, onguenti e balsami la ne insegna. (22/7)
Santa Poinara, la vecia (galina) sora la caponara.
Santi che pissa in tera no ghe n’è.
Scherza co i fanti ma assa stare i Santi.
Se ‘l dì de San Martin el sole se insaca, vendi el pan e tote la vaca; Se ‘l va zo seren, vendi la vaca e tiente el fen.(11/11)
Se a San Medardo piova, dopo quaranta dì rifà la prova. (8/6)
Se Dio no vole, gnanca i Santi pole.
Se fà belo a San Gorgon la vendema va benon.
Se fà fredo a San Luigino, farà caldo a San Paolino. (21/6-22/6)
Se Nadale vien senza luna, chi ga do vache se ne magna una.
Se no piove a San Medardo piove a San Gervasio. (19/6)
Se no te me vidi de San Giusepe patriarca, o che son perso o che son in aqua. (19/3)
Se piove a Pentecoste, tute le entrate no le xe nostre.
Se piove a San Bàrnaba la ua bianca la va via; se piove da matina a sera, va via la bianca e anca la nera.
Se piove a San Duane se suga le fontane.
Se piove a San Giorgio ghe sarà carestia de fighi.(23/4)
Se piove a San Gregorion, piove tuta la stajon. (3/9)
Se piove a San Paolo e Piero, piove par on ano intièro. (29/6)
Se piove a San Vito e Modesto, la ua va torla col zesto.(15/6)
Se piove a Sant’Ana, la xe na mana.
Se piove a Sant’Urban ogni spiga perde on gran.
Se piove a Santa Bibiana, piove par quaranta dì e ‘na setimana.
Se piove a Santa Desiderata, casca la ua e resta la grata. (14/6)
Se piove ai quaranta Santi, aqua par altretanti.
Se piove da la Madona, la xe oncora bona.
Se piove de San Duane, fen e paja deventa loame.
Se piove de San Gorgon, sete brentane e on brentanon.
Se piove el dì de San Gorgonio, autuno demonio.
Se piove el dì de Santa Crose el fà cascare le nose.
Se piove par San Vio al vin còreghe drio.
Se piove sole Palme no piove sui ovi.
Se San Michele no se bagna le ale, farà belo fin a Nadale.
Se San Michele se bagna le ale, piove fin a Nadale.
Se Sant’Antonio fa el ponte, San Paolo lo ronpe.
Se vènta* ai tri de Marzo e al dì de San Gregorio, vènta par quaranta dì. (12/3)
Se’l tona el dì de San Duane, le cuche va sbuse e le nosèle vane. (24/6)
Numero Proverbi: 250
SCHEI: I SCHEI GA SENPRE DÀ PENSIERI…
A chi che ga denaro forte, quando l’è vecio se augura la morte.
Al son de la canpana (schei) ogni dona se fa putana.
Ale làgreme de on erede xe mato chi che ghe crede.
A torghene e no metarghene ogni mucio cala.
Articolo quinto: chi che ga i schei ga senpre vinto.
Bisogna fare la spesa secondo l’entrata.
Bon marcà sbrega la borsa.
Botega de canton fà schei ogni cojon.
Cadena tirà fà la pase in ca’.
Chi ara fondo guadagna on mondo.
Chi che bastona el so cavalo bastona la so scarsela.
Chi che dispreza conpra.
Chi che ga paura del diavolo no fà schei.
Chi che ga schei ga senpre rason.
Chi che ghe n’a ghe ne spende.
Chi che paga avanti el trato, servizio mal fato.
Chi fida nel loto no magna de coto.
Chi ga canpi canpa.
Chi no tien conto de on scheo, no vale on scheo.
Chi òrdena paga.
Chi pì spende manco spende.
Chi sbaglia de testa paga de scarsela.
Chi sparagna el gato magna.
Chi sparte e no se ne tien, el Signore no ghe vole gnanca ben.
Chi va al marcà co pochi schei li spende male.
Chi vol vèndare mete in mostra.
Co zento pensieri no se paga on scheo de debito.
Co’ no ghe n’è, spèndarne; co’ ghe n’è tegner da conto.
Co’ piase la roba no se varda la spesa.
Co’ se ga da pagare se cata tuti, co’ se ga da tirare no se cata nissuni.
Co’ se guadagna se magna.
Conpra poco e guadagna tanto.
Da tristi pagadori se tole ogni moneda.
Debito sputanà, debito pagà.
Dove che ghe xe canpagne ghe xe putane.
El bon vin, i schei e la bravura poco i dura.
El malà no magna gnente e ‘l magna tuto.
El marzaro*, prima el fà i schei e dopo la cossienza.
Fare i mistieri che no se conosse i dìnari i deventa mosche.
Fin che dura i bezi*, amighi no manca. * (schei)
I cojuni del can e i schei del vilan i xe i primi mostrà.
I doluri xe come i schei: chi che li ga se li tien.
I schei fà balare i sorzi.
I schei no i ga ganbe ma i core.
I schei porta l’oca al paron.
I schei vien de passo e i va al galopo.
I siuri ga el paradiso de qua e quelo de là i se lo conpra.
In casa strinzi, in viajo spendi, in malatia spandi.
L’amore xe potente, ma l’oro onipotente.
L’avaro farìa de manco de cagare par no butare via gnanca quela.
L’omo da vin no ‘l vale on quatrin.
L’omo pì bruto xe quelo che ga le scarsèle roverse.
L’oro no ciapa macia.
La coéga cola sol lardo.
La merda fà schei.
La pignata de l’artesan, se no la boje oncuò la boje doman.
La roba no xe de chi che la fà, ma de chi che la gode.
La roba ordenà la vol èssare pagà.
Mèjo ‘vere du schei de mona che passare par massa svejo.
No ghe n’è mai a bastanza se no ghe ne vanza.
No spèndare tuto quelo che se ga, no dire tuto quelo che se sa.
On bel ciapare fà on bel spèndare.
On bon vèndare fà on bon guadagno.
Oro bon no ciapa macia.
Pare che guadagna, fioi che magna.
Quelo che no vien dala porta vien da l’orto.
Salute, amore, schei e tenpo par gòdarli.
Schei de zogo sta on ora par logo.
Schei e amicissia orba la giustissia.
Schei, poderi e canpi e na bela coa davanti.
Se fà spira la man drita, schei da dare; se fà spira la man zanca, schei da tirare.
Senza schei no se spende, senza laoro se dipende.
Senza stola no se confessa, senza schei no se canta messa.
Spendi la moneda par quelo che la vale.
Tuti i mistieri fà le spese.
Numero Proverbi: 75
STAGION: OGNI PROVERBIO PAR LA SO STAJON
A l’istà piove a contrà.
A San Clemente l’inverno mete el dente.(23/11)
Beato l’Istà co tuti i pulzi e i zìmesi che’l ga.
Candelora, de l’inverno semo fora, ma se piove e tira vento de l’inverno semo drento.
Cativo inverno, cativo istà.
Chi no sa cossa che xe l’inferno, fassa el cogo d’istà e ‘l caretier d’inverno.
Co l’Adolorata se va verso l’invernata.
Co’ canta el ciò xe finio de far filò.
Co’ névega sola foja l’è on inverno che fa oja.
Co’ te senti le racolete cantare xe rivà la Primavera.
De istà ogni beco fà late, de inverno gnanca le bone vache.
El capon xe senpre de stajon.
El marangon laora senza stajon.
Febraro inevà fà bela l’istà.
Fin a Nadale fredo no fà: braghe da istà; dopo Nadale el fredo xe passà, braghe da istà.
I dì dela merla l’inverno te dà na sberla.
I du Santi del giazo: San Luigino e San Paolino i porta l’Inverno de Giugno.
In istà la vache va in montagna a fare le siore, e le siore va in montagna a fare le vache.
L’inverno l’è el boia di’ veci, el purgatorio di’ putei e l’inferno di’ poariti.
L’istà de San Martin dura tri dì e on pochetin.
L’onbra d’istà fà male ala panza d’inverno.
La piova de primavera ghe ronpe la rogna ala tera.
La piova del’Assension fà bela la stajon.
Miti le straze int’on canton che vegnarà la so stajon.
Né de inverno, né de istà tabaro e onbrela mai a ca’.
O dal cao o dala coa l’inverno vol dire la soa.
Pan, vin e zoca, lassa pur che’l fioca.
Par el seco xe bona anca la tenpesta.
Par San Barnabà el dì pì longo de l’Istà.
Par San Matio le jornade torna indrio.
Pèrsego e melon tuto ala so’ stajon.
Piova d’Istà, beati che che la ga.
Piove pì àneme al’inferno che neve de inverno.
Primavera de Jenaro la ruina el persegaro.
Primo de Agosto, capo de inverno.
Quando che piove el dì de San Gorgon, piove par na stajon. (9/9)
Quando che te magni la nèspola, pianzi.
Quando che’l sorgo rosso el mostra el muso, xe ora de tore la roca e el fuso.
Quando el Venda fa el pan, se no piove oncuò, piove doman.
Quando le done fa la lissia sola via, l’inverno sbrissa via.
Se piove a San Gregorion, piove tuta la stajon. (3/9)
Stajon de erba, stajon de merda.
Stropa longa, inverno longo; stropa curta, inverno curto.
Vin, done e maroni bisogna gòdarli so’ la so stajon.
Numero Proverbi 44
SPOSI: TUTO SOL SPOSALIZIO
A tola e leto no se porta rispeto.
Amarse, ma no buzararse.
Assa che la mojère la comanda in casa: solo cussì la te struca e la te basa.
Beata chela sposa che la prima che la ga la sia na tosa.
Chi che ga na bela mojère no la xe tuta soa.
Chi che se marida de carnevale slonga le ganbe e scurza le bale.
Chi che se marida e no sa l’uso, fa le ganbe fiape e longo ‘l muso.
Chi che se marida vecio sona de corno.
Chi che vole justare le braghe co le còtole dela mojère le gavarà senpre rote.
Chi dise sposa dise spesa.
Co’l galo canta da galina, la casa va i ruina.
Conpare de anelo pare del primo putelo.
De San Martin se sposa la fiola del contadin.
Dentro de ogni matrimonio se sconde el demonio.
Dio li fà e po’ li conpagna.
Dopo i confeti se vede i difeti.
El matrimonio no xe belo se no ghe xe gnanca on putelo.
El primo ano se ghe vole tanto ben che la se magnaria, el secondo se se ciama grami de no verla magnà.
Fin che na bela xe vardà, na bruta xe maridà.
Fumo e dona ciacolona fà scanpare l’omo de casa.
I fioi vien dal cuore, el marìo dala porta.
L’omo fà la dona e la dona fà l’omo.
L’omo maridà porta quatro “p”: pene, pensieri, pentiminti e pecati.
La bona mojère fà el bon marìo.
La prima fachina, la seconda regina.
La prima xe matrimonio, la seconda conpagnia e la terza na eresia.
La roba marida la goba.
Leto fato e fémena petenà, la casa xe destrigà.
No ghe xe matrimonio che no ghe entra el demonio.
Novantanove maridà fà zento bechi.
Omo maridà, oselo in gabia.
Quando che’l Signore vuole castigare uno el ghe manda l’ispirazion o de sposarse, o de torse on musso o on’ostaria.
Quando Dio vol castigar on omo el ghe mete in testa de maridarse.
Quando la mojère se mete le braghesse, al marìo no ghe resta che le còtole.
Scarpe grosse e marìo bruto, va tranquila dapartuto.
Se te ghe na bruta mojere, va in leto al scuro.
Signore, fà ca no sia beco; se ghe so’, fà ca no lo sapia; se lo sò, fà ca no ghe bada.
Zapa sposa baile.
Numero Proverbi: 38
VIN: TUTO SOL VIN E TORNO VIA
A chi che no ghe piase el vin , che Dio ghe toga anca l’aqua.
A San Baldoin se fa el vin.
A San Crispin se pesta el vin.(25/10)
A San Martin casca le foje e se beve el bon vin.
A San Martin el mosto deventa vin.
A San Martin se spina el bon vin.
A San Martin, castagne e vin.
A San Pelegrin, poca paja e poco vin. (5/5)
Aqua de Agosto, miele e mosto.
Aqua setenbrina, velen par la cantina.
Bianco e moro méname a casa.
Bieta e vin juta el segantin.
Bivi el vin e lassa l’aqua al mulin.
Bon fogo e bon vin scalda el camin.
Bon vin, fola longa.
Bona bota bon vin, trista bota tristo vin.
Bota che canta la xe voda.
Bota piena, cèsa voda.
Chi che ghe piase el vin no’l lo buta in aseo.
Chi vol fare mosto zapa la tera de Agosto.
Co’l cavéjo tra al bianchin, assa la dona e tiente el vin.
Co’l mulin xe senza aqua me toca bévare aqua; co’ l’aqua fà ‘ndare el mulin bevo del bon vin.
Dona bela e vin bon xe i primi che te assa in abandon.
Dove che no ghe xe vin da travasare e farina da far pan staghe lontan.
El bon vin fà bon sangue.
El bon vin se trova dal paroco.
El bon vin se vende a la soja.
El bon vin xe ciaro, amaro e avaro.
El bon vin, i schei e la bravura poco i dura.
El pèrsego col vin, el figo co l’aqua.
El pesse ga da noare tre volte: prima ‘ntel’aqua, dopo ‘ntel’ojo e la terza ‘ntel vin.
El primo fiore xe quelo del vin.
El riso nasse da l’aqua e ‘l ga da morire sol vin.
El vin al saore, el pan al colore.
El vin amaro tièntelo caro.
El vin bon no ga bisogno de frasca.
El vin de casa no inbriaga.
El vin xe bon par chi che lo sa bévare
El vin xe el late di’ veci.
Faustin, poco pan e tanto vin.
Formajo, pan bianco e vin puro fà el polso duro.
Giugno, Lujo e Agosto, né dona, né aqua, né mosto.
L’omo da vin no ‘l vale on quatrin.
L’ultimo goto xe quelo che inbriaga.
La bota la dà el vin che la ga.
La bota la fà el vin.
La bota piena tase.
La piova de San Bernardin la roba pan, ojo e vin.
Le canpane de San Martin vèrze le porte al vin.
Majo piovoso, vin costoso.
Maroni e vin novo, culo mio te provo.
Maroni e vin novo, scoreze de fogo.
Marsoni friti e polentina, on fià de vézena e vin de spina.
No bisogna domandarghe a l’osto se’l ga bon vin.
Ogni vin fà alegria se’l se beve in conpagnia.
Ovo de on’ora, pan de on dì, vin de on ano, dona de quìndese e amigo de trenta.
Pan che canta, vin che salta e formajo che pianza.
Pan fin che’l dura, vin a misura.
Pan padovan, vini visentini, tripe trevisane e done veneziane.
Pan, vin e zoca, lassa pur che’l fioca.
Par Sant’Antonin, poca paja e poco vin.
Pitosto che spàndarghene on jozo xe mejo bévarghene on pozo.
Polenta nova e osei de riva, vin de grota e zente viva.
Quando a Novenbre el vin no xe pì mosto, la pitona xe pronta par el ‘rosto.
Quando che l’omo xe pien de vin el te parla anca in latin.
Quando che’l vin no xe pì mosto, la castagna xe bona a rosto.
Quando se travasa se beve.
Se Giugno sguaza poco vin in taza.
Se no fa caldo a Lujo e Agosto sarà tristo el mosto.
Se piove par San Vio al vin còreghe drio.
Se te ghe poco vin, véndite anca el tin.
Vin de fiasco: ala sera bon, ala matina guasto.
Vin novo, braghe leste.
Vin vecio e dona zòvane.
Vin, done e maroni bisogna gòdarli so’ la so stajon.
Vinti munari, vinti sartori e vinti osti fà sessanta ladri.
Numero Proverbi: 76
FONTE: da DIALETTO VENETO EL SITO DEL MAESTRO
Link: http://www.dialetto-veneto.it/Proverbi.htm
Link: http://www.dialetto-veneto.it